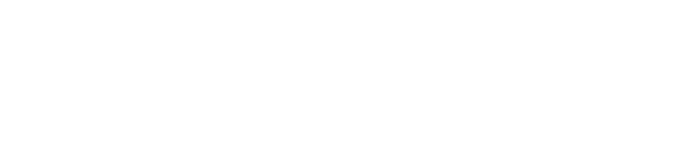Recensione. Miguel Gotor, Generazione Settanta, Einaudi 2022
Miguel Gotor, Generazione Settanta, Einaudi 2022
Miguel Gotor, attento studioso delle carte Moro, dei memoriali, dei tanti processi e commissioni d’inchiesta, dei documenti rinvenuti e delle testimonianze succedutesi negli anni, si è posto un obiettivo ambizioso: tracciare una sintesi degli anni Settanta che parli a chi li ha vissuti e alle nuove generazioni. Come ha dichiarato in un’intervista:
“Il libro parla soprattutto a chi ha superato i settant’anni ma c’è anche il rapporto con chi è giovane e può avere voglia di ripercorrere la storia del nostro Paese per capire l’oggi. Ẻ difficile sperare di parlare a entrambi i pubblici, il mio sogno è di riuscirci”.
Per chi ha superato i settanta come chi scrive il suo lavoro parla solo parzialmente, e dubito che un giovane d’oggi riesca a districarsi nel complesso quadro che ricostruisce e a recepirne un messaggio e un filo conduttore che aiuti alla comprensione.
Molto apprezzata se non osannata nelle recensioni di Riotta e Mughini questa narrazione di uno storico che si misura con gli anni della sua infanzia risulta affastellata e farraginosa, nell’alternarsi di riassunti cronachistici tratti dalla stampa dell’epoca e voli poetici che attingono ai cantautori e a Montale. C’è un problema di metodologia rispetto alle fonti, che a volte rasentano il pettegolezzo o le ricostruzioni giornalistiche non verificate, ed un eccesso di dietrologia, avendo per anni l’autore perseguito piste che aiutassero a spiegare i tanti lati oscuri della strategia della tensione e degli intenti destabilizzatori che hanno segnato quegli anni.
Se devo azzardarmi ad interpretare la tesi di Gotor in soldoni (e spero di non aver frainteso un testo la cui leggibilità non è delle migliori, non solo per i caratteri tipografici scelti dalla casa editrice per ridurre il numero delle pagine) ci sarebbe una cesura tra i tentativi golpisti ed il terrorismo nero dei primi anni Settanta e l’uso destabilizzante delle azioni armate brigatiste a partire dal 1974, in una sorta di patto scellerato tra apparati di sicurezza e brigatisti e loro emuli che consisteva in un sostanziale laissez faire per profittare di un clima di paura e terrore ai danni della democrazia. Il tutto condito da intervento dei vari servizi stranieri dal Mossad al KGB alla CIA e dai patti stretti con l’OLP sotto l’egida del colonnello Giovannone. Solo dopo Moro si innesca una controffensiva dello Stato ad opera di Dalla Chiesa e dei carabinieri, peraltro lasciati spesso isolati, per infiltrare i brigatisti e inaugurare la stagione del pentitismo e della dissociazione, in una sostanziale omertà ai danni della verità. Questa del resto sembra la chiave di lettura offerta anche dallo sceneggiato televisivo Roma di piombo, cui Gotor ha collaborato insieme a Bianconi, in un’operazione mediatica che esalta l’arma dei carabinieri e il loro ruolo fondamentale nello sgominare la colonna romana delle BR, dando spazio a interventi a ruota libera di Piccioni e Persichetti, brigatisti non dissociati.
Questo di Gotor è un libro pieno di notizie ed elementi di informazione, ma privo di una narrazione empatica: paradossalmente è come se mancasse un punto di vista, quel “centro di gravità permanente” smarrito cantato da un disincantato Battiato sventolando la bandiera bianca. Recentemente Enzo Traverso nella Tirannide dell’io ha deprecato l’eccesso di protagonismo nelle nuove narrazioni degli storici: in questo saggio di Gotor l’io sembra invece mancare, anche se si avverte una forte antipatia per il Sessantotto, i suoi eccessi, le sue derive ed i suoi fallimenti.
Gotor cita Curcio che dichiara: «Ci sono tante storie di questo Paese che vengono taciute, che non potranno essere chiarite per una sorta di sortilegio, come piazza Fontana, come Calabresi, che sono andate in un certo modo e che, per ventura della vita, nessuno può dire come sono veramente andate… C’è stata una sorta di complicità tra noi e i poteri che impedisce a noi e ai poteri di dire come è veramente andata». Lui stigmatizza questa «formula criptica e reticente, ma al fondo indulgente e autoassolutoria, nella quale tutti i superstiti di questa tragica storia, per la loro quota parte di responsabilità, e da qualsiasi lato della barricata avessero militato, si sarebbero potuti riconoscere. […] Tutti, tranne i morti». L’omertà e la mancata chiarezza sarebbero all’origine della disaffezione dalla politica, «radicalizzando in milioni di cittadini un sentimento di sfiducia, d’impotenza e di disillusione nell’azione collettiva, di disimpegno e di ripiegamento nel privato».
La premessa del volume intreccia Gigliola Cinquetti di Non ho l’età, con le riviste della Nuova Sinistra e il convegno del Parco dei Principi che inaugura la strategia della tensione e la stagione golpista. La conclusione è il ritrovarsi dell’Italia nei festeggiamenti della vittoria della nazionale ai mondiali di calcio del 1982 e il film di Moretti La messa è finita che chiude con i sogni e le utopie.
Forse c’è troppa carne al fuoco, ed un fuoco che ancora brucia, per una sistemazione a freddo di anni che hanno segnato la nostra storia. I capitoli più efficaci corrispondono alle ricerche fatte dall’autore stesso sul caso Moro e il suo contesto mentre altri risultano eccessivamente compilativi. Sullo sfondo la politica e la società, anche se vengono enumerati i governi e le loro composizioni e riforme fondamentali come il divorzio e l’aborto. Le ricerche su quegli anni e le narrazioni sono ancora in fieri ed è forse ambizione eccessiva tentare di mettere assieme tutti i tasselli.
Silvia Calamandrei