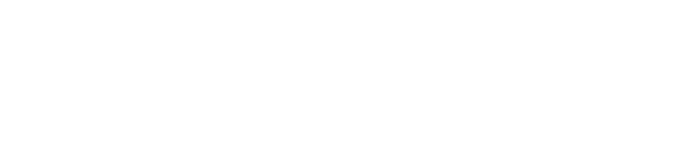Comunicazioni
LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI
Anche questa Estate la Biblioteca di Montepulciano offre ai suoi piccoli lettori (dai 3 ai 9 anni) laboratori settimanali legati alle storie, ai libri ma anche al “fare” qualcosa tutti insieme.
leggi la locandina per scoprire cosa abbiamo pensato per Voi!
ELIO BERNABEI ricordato da Silvia Calamandrei durante la presentazione del libro di Mario Avagliano
Ricordando Elio Bernabei a Montepulciano nell’80mo anniversario della strage delle Ardeatine i familiari ci hanno donato alcuni preziosi documenti che attestano come già dalle prime commemorazioni il suo sacrificio ha nutrito lo spirito di resistenza e di costruzione di una nuova Italia, democratica ed antifascista.
Nel funerale tenuto a Montepulciano nel gennaio del 1945, con il Nord Italia ancora impegnato nella battaglia contro i nazifascisti, l’esempio di Bernabei è stato evocato in funzione della resistenza e della ricostruzione, e così è avvenuto nel ricordo a Roma, nel primo anniversario, da parte dei suoi compagni ferrovieri.
Bernabei è uno dei tanti resistenti che furono rastrellati nelle carceri di Roma, con la collaborazione dei fascisti italiani che ne compilarono la lista, per alimentare la sete di vendetta degli occupanti nazisti che sarebbero di lì a poco stati scacciati. Ed oggi lo ricordiamo insieme ad altri caduti quel 24 marzo del 1944, in questo itinerario per l’Italia che Avagliano e Palmieri stanno conducendo nei luoghi di origine dei martiri, ricostruendone le radici molteplici, ma tutti uniti da un impegno di resistenza e di aspirazione ad un mondo migliore, un filo rosso che traccia la variegata storia della resistenza al nazifascismo, articolata nei vari territori ma unita da uno spirito comune che avrebbe consentito di porre le basi della nostra Costituzione.
Fin dall’annuncio di questo itinerario ci siamo riproposti di aderire e di condividerlo, poiché il monumento ai caduti delle Ardeatine può essere considerato il vero monumento della resistenza italiana, quello che nella lapide ad ignominia a Kesselring veniva così descritto.
Ma soltanto col silenzio del torturati
più duro d’ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità e non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.
Ci piace ricordare un passo del discorso che tenne il Sindaco di Montepulciano Lucangelo Bracci Testasecca, prima che l’intera Italia fosse liberata, un passaggio che sottolinea la consapevolezza della scelta di Bernabei- smentendo chi a sostenuto che “furono uccisi solo perché italiani”. Pensa alle riflessioni che avrà avuto nelle sue “tristi notti d’ostaggio”:
“sapendo di essere ostaggio (ed essere ostaggio di tedeschi e di fascisti) e sapendo, per averne fatto parte, che fuori della prigione non sarebbero mancati gli atti ardimentosi dei suoi compagni che avrebbero compiuto quel gesto che lo avrebbe condotto al supplizio”.
E ne trae incoraggiamento per il “lavoro lento e faticoso della ricostruzione”, invocando uno spirito d’unità che era venuto meno all’indomani della Grande Guerra. Non a caso rievoca le manifestazioni del 1922 a Montepulciano, in onore del Milite ignoto, che furono turbate dalle violenze squadriste e fa riferimento alla lapide ancora oggi nel cortile del Palazzo comunale in onore dei caduti della Grande Guerra. Fu una lapide di discordia, come è stato rievocato in un volume a suo tempo pubblicato, e nel 1945 Bracci incoraggia ad avanzare in concordia nell’opera di ricostruzione.
Mentre Bernabei veniva accolto nel cimitero di Santa Chiara la lotta di liberazione era ancora in corso, e in questo ottantesimo che celebra la liberazione del Centro Italia possiamo meglio renderci conto di quanto la resistenza sia stata articolata e variegata nelle varie parti d’Italia. Lo stesso Bernabei, commemorato dall’Azione cattolica e dal Partito d’Azione di Montepulciano per la sua appartenenza al gruppo dei cristiano sociali quivi formatosi tra i giovani, cadeva pochi giorni prima della vittoriosa battaglia di Monticchiello in cui combatterono alcuni dei suoi compagni ed amici. E in quei giorni Piero Calamandrei si amareggiava in Umbria sulle sorti della sua Toscana e dei suoi compagni fiorentini, senza notizie da Montepulciano. Realtà diverse anche a poche centinaia di chilometri di distanza.
Rievocare oggi insieme alcuni dei caduti alle Fosse Ardeatine, originari di questi territori, ci aiuta a consolidare una identità condivisa, fondata sul lascito iscritto nella nostra Costituzione dalla resistenza civile ed armata al nazifascismo.
[Silvia Calamandrei]
E’ on line il PORTALE CARTEGGI PIERO CALAMANDREI “Un caleidoscopio di carte”
On line le scansioni dei documenti della corrispondenza di Piero Calamandrei!
questo il link:
Archivio Calamandrei – Un caleidoscopio di carte
Le quattro istituzioni che custodiscono le carte di Piero Calamandrei (l’ISRT di Firenze, la Biblioteca Archivio Piero Calamandrei di Montepulciano, la Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei di Roma e la Fondazione Museo storico del Trentino), riunite nel progetto di inventariazione e digitalizzazione di tale patrimonio documentario, annunciano la presentazione il 14 maggio alle 15.30, nella sede della Soprintendenza archivistica della Toscana ( Firenze ,via dei Ginori 7) della strumentazione per la consultazione in rete dei carteggi di Piero Calamandrei.
Grazie agli sforzi congiunti e ai finanziamenti della Direzione generale Archivi del Ministero della cultura, nonché alla preziosa collaborazione della Soprintendenza Toscana che ci ospita, è stato possibile realizzare una prima significativa tappa del percorso delineato nel convegno “Un caleidoscopio di carte” del 2009 a Montepulciano, sotto il patrocinio della Presidenza della Repubblica, per mettere a disposizione degli studiosi e del pubblico le carte del giurista e costituzionalista su una piattaforma digitale.
RECENSIONI. Fosse Ardeatine e via Rasella: nuove ricostruzioni e narrazioni nell’80mo anniversario
Fosse Ardeatine e via Rasella: nuove ricostruzioni e narrazioni nell’80mo anniversario
Lutz Klinkhammer e Alessandro Portelli, La fiera delle falsità, Donzelli 2024
Mario Avagliano e Marco Palmieri, Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine, Einaudi 2024
Dino Messina, Controversie per un massacro, Solferino 2024
Antonio Iovane, Il carnefice, Mondadori 2024
Nell’ottantesimo dal massacro delle Fosse Ardeatine, vendetta efferata nazifascista dopo l’attentato del 23 marzo contro i Bozen che sfilavano a via Rasella, molte trasmissioni televisive, saggi e romanzi sono intervenuti a rivisitare quegli eventi, sgombrando il campo dalle tante falsificazioni o vulgate e ripristinando il contesto e la sequenza dei fatti in quella primavera romana che prelude alla Liberazione.
Il dialogo tra uno storico tedesco e italiano, Klinkhammer e Portelli, oltre a fornire tante precisazioni sull’occupazione tedesca a Roma, la composizione delle sue forze militari e di polizia e la natura del corpo di polizia di origine altoatesina, nonché sulla dinamica decisionale della “rappresaglia” (non ci fu nessun ordine scritto di Hitler) e le reazioni in seno ai comandi del CLN, si interroga sulle ragioni delle distorsioni interpretative, intervenute fin dal primo commento dell’”Osservatore romano”. I due studiosi si soffermano anche sulle responsabilità fasciste italiane nella selezione dei condannati e più in generale sui crimini di guerra di cui il fascismo italiano si è macchiato.
Portelli definisce la strage come “l’unica vera strage metropolitana in Occidente. La composizione delle vittime riflette la demografia del paese: tutte le regioni, tutti i quartieri, tutti i mestieri, tutte le identità politiche e religiose, tutte le età…c’è dentro l’Italia intera. Le Fosse Ardeatine dovrebbero essere il vero monumento all’unità nazionale”.
Si può dire che Avagliano e Palmieri lo abbiamo preso in parola offrendoci le storie delle 335 vittime dell’eccidio, una sorta di Spoon River italiana, composta grazie all’accurato lavoro condotto negli anni dall’Anfim (Familiari vittime) con l’ausilio del Museo della Liberazione di Roma, il Ministero della Difesa, l’ANPI e la Comunità ebraica, per mettere a punto le schede biografiche e portare a termine i riconoscimenti, anche grazie a tecniche più sofisticate di identificazione. Solo tre dei caduti restano non identificati, mentre ai 335 si è aggiunta una donna, uccisa perché stava raccogliendo cicoria nelle vicinanze ed era un testimone da sopprimere.
Tra le biografie anche quella dell’ingegnere poliziano Elio Bernabei, protagonista attivo della resistenza romana per il Partito d’Azione. Un monumento alla memoria che ha la valenza delle Lettere dei condannati a morte della resistenza e che giustamente viene presentato in tutta Italia con un percorso itinerante degli autori che toccherà anche la nostra zona. Leggendo si constaterà che non sono stati “uccisi solo perché italiani”, come ha dichiarato qualcuno, ma che oltre ai tanti ebrei la grande maggioranza apparteneva alla Resistenza al nazifascismo.
Sintesi divulgativa assai completa ed accurata è quella di Sebastiano Messina, che offre anche una bibliografia essenziale ed una panoramica delle diverse interpretazioni e prese di posizione (Ottant’anni di polemiche) dopo una narrazione dei fatti e dei processi che seguirono, fino a quello a Priebke e alla sentenza del 1999 della Cassazione che ribadisce che l’azione di via Rasella fu “legittimo atto di guerra”.
Per una narrazione avvincente della vicenda Priebke che si legge come un romanzo giallo, e in cui l’autore si implica e si interroga interagendo coi fatti e coi protagonisti, bisogna affidarsi alla narrazione di Antonio Iovane, già maestro di intrecci su fatti storici recenti a proposito del brigatismo e del sequestro Moro.
[Silvia Calamandrei]
RICORDI DI GIUSEPPE MOMICCHIOLI. Trascrizione di una registrazione a cura di Judith Pabian
TRASCRIZIONE IN SINTESI DELLA REGISTRAZIONE
Giuseppe Momicchioli
lunedi’ 2 maggio 2016
Gruppo b, residenti sopravvissuti
Nato il 20 maggio 1934 a Montepulciano (Vecchio Ospedale).
Giuseppe era il quarto figlio e ultimo figlio della sua famiglia. I suoi tre fratelli morirono da piccoli prima della sua nascita. Alla sua nascita sua madre aveva 40 anni e il padre 41. All’inizio la famiglia (Giuseppe, il padre, la madre e i nonni) abitava nel piccolo Borgo di San Pietro sotto la Fortezza. Poi si trasferirono a via Roma al numero 18, – la stessa via in cui abitava Bozzini così come quasi tutti gli altri membri del Partito Socialista.
La famiglia di Giuseppe è nativa di Montepulciano. Nel 1600 a Montepulciano c’erano 50 famiglie che si chiamavano Momicchioli. (Altri cognomi della zona: Del Toro, Bozzini, Mangiavacchi).
Durante la guerra lui era ancora ragazzo e andava regolarmente alla messa nella chiesa di S. Agostino. La chiesa era un luogo d’incontro per i ragazzi, dove venivano organizzate sia attività ricreative che educative. La parrocchia offriva aiuto scolastico. Infatti Giuseppe è ancor oggi estremamente grato per ciò che la chiesa fece per lui a quell’epoca.
La famiglia del padre era di origine contadina. Nel 1912, a 18 anni, il padre di Giuseppe (suo Babbo) andò militare e poi volontario nella Prima Guerra Mondiale fino al 1919. Pertanto fece tutte le maggiori battaglie durante la guerra (combatte’ sul fronte al Piave, Isonzo, sul Carso).
Si sposò nel 1920 al ritorno dalla guerra.
Il padre e la madre di Giuseppe si fidanzarono prima della guerra. La famiglia della madre tuttavia era molto numerosa (9 figli, di cui 5 femmine) e povera. Nel 1917-18, il nonno di Giuseppe organizzò il fidanzamento e il matrimonio di due delle figlie che si sarebbero dovute sposare lo stesso giorno.
Il giorno del matrimonio, già sull’altare di fronte al prete, la madre di Giuseppe si rifiutò di sposare l’uomo che il padre le aveva scelto.
Il padre di Giuseppe tornò dalla guerra nel 1919 e nel 1920 i suoi genitori si sposarono.
Dopo la guerra divenne un operaio agricolo. In realtà il comune offriva come ricompensa ai reduci di guerra un posto come vigile urbano. Il padre inizialmente accettò il posto, ma poi quando gli dissero che per avere quel posto bisognava iscriversi al partito fascista rifiutò. All’epoca coloro i quali si allineavano alla visione socialista non si chiamavano veramente socialisti ma “liberi pensatori”.
Nel 1936, il padre di Giuseppe comperò un orto vicino alle mura che pagò 6.000 lire. L’orto fu la fortuna della famiglia perché durante la guerra forniva tutto il necessario per la prima sopravvivenza (frutta, verdura ecc.). Nel 1941 con i ricavati dell’orto, il padre di Giuseppe acquistò un piccolo negozietto di generi alimentari per la madre. In realtà quando venne la guerra non fecero particolare fortuna, perché durante la guerra non c’era niente da vendere. Ad un certo punto l’avevano quasi riconvertito e vendevano cordami, mestoli ecc., tutto ciò che si trovava in commercio e poteva essere rivenduto. Giuseppe ricorda che il padre una volta andò addirittura fino ad Arezzo in bicicletta per prendere cose da vendere nel negozio.
La gente si procurava il cibo nelle campagne. In paese c’era molto poco e il commercio avveniva con il baratto tra la gente di città e i contadini. Tutti si accontentavano di molto poco.
Giuseppe durante la guerra aveva 10 anni.
Nel campanile di S. Agostino ci sono 4 finestre circolari con una feritoia centrale in cui c’erano 4 mitragliatrici con 4 partigiani. Uno dei partigiani era un vicino di Giuseppe. La mamma tutti i giorni gli mandava il pranzo e Giuseppe era responsabile per portare il pacchetto del cibo. Il parroco sapeva che questo avveniva e lasciava sempre aperto il passaggio.
Un giorno al ritorno dal campanile di S. Agostino, due ufficiali tedeschi guardavano e indicavano il campanile. Giuseppe tornò in chiesa, avvertì il prete che a sua volta avvertì i partigiani. Quando il prete tornò fuori dalla chiesa, i tedeschi erano spariti. Forse c’era stato un fraintendimento e gli ufficiali stavano semplicemente osservando la bellezza del campanile.
Giuseppe non portava mai messaggi, solo il cibo. C’erano delle persone che sapevano della presenza dei partigiani e dove erano dislocati. Da una parte c’era il vescovo Giorgi che mandava messaggi ai partigiani. Il vescovo aveva dei referenti in campagna, che a loro volta informavano i contadini nei boschi.
Le campagne erano schierate chiaramente con i partigiani. Ovviamente c’erano anche delle spie, ma queste spie erano ben conosciute e quindi si stava molto attenti. Le campagne erano molto importanti. Tutte le azioni partigiane vennero supportate dai contadini.
Tra partigiani c’erano comunisti, socialisti, demo-cristiani, indipendenti (cioè apolitici, coloro che si erano rifiutati di essere militari o coloro che non erano ancora partiti che avevano all’incirca 20 anni). Tutti collaboravano indipendentemente dalla tendenza politica.
Dopo la guerra Giuseppe diventò medico. Il sindaco Berti, che era anche presidente dell’ospedale, gli voleva dare la precedenza per una posizione in ospedale perché si ricordava del fatto che Giuseppe aveva aiutato nel portare il cibo ai partigiani durante la guerra. Giuseppe rifiutò l’offerta e decise di fare il medico libero professionista.
Durante l’occupazione della zona ci furono numerose azioni dei partigiani. Ad esempio i fatti di Pianoia (tra Montepulciano e Monticchiello): i fatti di Pianoia avvennero per colpa di una spia. A Pianoia c’era un gruppo di partigiani rifugiati dentro una villa, tra cui il capo dei partigiani Vincenzo Cozzani (vice-comandante generale). Durante l’attacco Cozzani stava scrivendo una lista di tutti i partigiani della zona. Quando venne avvertito dell’attacco dei tedeschi, cercò di scappare dalla villa. I tedeschi gli spararono e venne catturato e portato in carcere a Torrita.
Durante il tragitto, vide due persone a piedi e riconobbe un amico (Gastone Marelli) a cui passò la lista dei partigiani.
Vincenzo Cozzani era un ex-marinaio militare che aveva nobili origini.
Non si sa se era monarchico o repubblicano.
Da Torrita lo trasportarono in carcere a Siena dove lo torturano psicologicamente e fisicamente per fargli dire i nomi di tutti i partigiani. Vincenzo non confessò.
Vincenzo riuscì a scappare insieme ad un compagno di cella tedesco che per errore aveva ucciso un altro tedesco. Vincenzo non voleva portare con sé il tedesco ma, preso da compassione, decise di portarselo con sé durante la fuga. Durante la fuga si fermò presso una casa di contadini che lo aiutarono.
Quando tornò a Montepulciano, Giuseppe, la sua famiglia e la famiglia di Cozzani erano dentro un rifugio anti-aereo (La famiglia Cozzani infatti abitava nella stessa casa di Giuseppe).
A mezzanotte bussarono alla porta del rifugio ed era il maresciallo dei carabinieri che era venuto ad informare la madre di Vincenzo che Vincenzo era fuggito dal carcere ma che stava bene.
Le madri non potevano aiutare i partigiani perché erano seguite dai tedeschi e controllate.
A Montepulciano c’era il comando dei tedeschi per tutto il tempo della guerra. Il comando tedesco era nella scuola.
Ci furono 2 fasi dell’occupazione della zona:
La prima fase, quando i tedeschi erano principalmente militari ed erano molto disciplinati. Un episodio: una volta un soldato semplice tedesco ubriaco aveva sparato contro la porta di un orefice in centro. Ad un certo punto, arrivò un ufficiale che cominciò a rimproverarlo e picchiarlo per quello che aveva fatto.
La seconda fase cominciò con l’arrivo della divisione di Hermann Goering. Costoro appartenevano tutti alle SS ed erano estremamente crudeli.
Le donne aiutavano i partigiani e sapevano tutto ciò che avveniva. Le donne che sapevano e aiutavano di più erano le donne contadine. Le mamme dei partigiani non avevano invece molte informazioni.
Il partito socialista di Montepulciano nacque nella bottega del barbiere dove venivano scambiate tutte le informazioni. Tra le persone che frequentavano il negozio del barbiere c’erano: Dr Del Corto, Avvocato Corsini, Calamandrei, Bernabei, Del Toro Cesare. Quando il barbiere venne scoperto fuggì insieme al maestro di scuola di Giuseppe e si rifugiò per un mese nel cimitero locale.
La gente aveva molta paura dei tedeschi. Una sera andarono a casa di Giuseppe a cercare delle armi e facevano molta paura.
I tedeschi con le donne si comportavano bene; Giuseppe non ricorda episodi di violenza. C’erano alcune donne locali che flirtavano con i tedeschi, ma erano comunque rare.
Mentre quando arrivarono le SS le donne stavano più attente. Ma Giuseppe non ricorda episodi di particolare violenza contro le donne.
Problemi con le donne avvennero più quando arrivarono gli Alleati e le truppe marocchine. I marocchini erano violenti con le donne e con gli animali. Non si sa quante donne furono assaltate dai marocchini.
I tedeschi consideravano il sapone una cosa molto importante perché ci tenevano particolarmente alla pulizia.
Dopo la guerra c’era molta povertà. La povertà era estesa a tutti, anche a coloro che prima della guerra erano signori e possedevano poderi.
A Montepulciano c’erano tutte le scuole fino al liceo (liceo classico, scientifico, ragioneria, scuola tecnica). Il liceo classico (che aveva frequentato Giuseppe) esisteva fin dal 1700 ed era inizialmente gestito dalla chiesa e si chiamava Liceo Ginnasio di Montepulciano. Uno dei migliori insegnanti sapeva ben 4 lingue.
Montepulciano era una città culturalmente elevata. C’era anche la scuola per i sacerdoti.
In campagna c’erano le scuole elementari. Spesso le maestre di Montepulciano andavano ad insegnare lì.
Giuseppe fece l’università a Siena. La scuola medica durava 6 anni ed era una delle migliori di Italia. Giuseppe ce la fece in 6 anni perché aveva un forte desiderio di voler salire di ceto. Giuseppe aveva una gran passione per la lettura, una grande fantasia e una fortissima memoria.
La signora di Monticchiello si chiamava Angheben. La figlia si chiama Lucia Angheben e abita a Bologna.
Dopo la guerra la signora Angheben una volta invitò la nostra classe di terza liceo a casa sua. Tutto il liceo andò a casa sua. La sua casa era bellissima con un gran giardino e un pozzo centrale.
Lei generalmente fece da traduttrice per i tedeschi per tutto il tempo in cui i tedeschi rimasero a Montepulciano.
Giuseppe ebbe un parente partigiano, era cugino di Giuseppe e abitava a Chianciano (ora morto). Un altro parente fece il partigiano in Sicilia e morì quando il suo sottomarino affondò.
La sua famiglia abitava a Chianciano.
RECENSIONE. Yang Jisheng , Lapidi, Adelphi 2024, traduzione di Natalia Francesca Riva
Yang Jisheng , Lapidi, Adelphi 2024, traduzione di Natalia Francesca Riva
Contro l’amnesia storica una indagine sui disastri del Grande Balzo in avanti
Quest’opera, arriva in Italia tardivamente, come tardivamente fu pubblicato Vita e destino di Grossman, e sempre per merito di Adelphi. Già note agli specialisti nelle loro versioni inglesi o francesi, queste opere marcano uno spartiacque conoscitivo perché sono testimonianze dall’interno sul funzionamento dei meccanismi totalitari, frutto di un’esperienza diretta e meditata, cariche quindi di vissuto personale e collettivo.
Per questo sarebbe opportuno che Adelphi proseguisse nel suo sforzo editoriale offrendo al pubblico italiano l’opera che ha fatto seguito a Lapidi, Rovesciare cielo e terra, la storia della Grande rivoluzione culturale, con la quale Yang Jisheng ha completato la sua ricostruzione degli anni del Maoismo in Cina. Entrambi i libri sono stati concepiti in Cina lavorando sulla documentazione disponibile, in una fase in cui gli archivi erano più facilmente consultabili, e sono frutto anche di tanti contatti e colloqui dell’autore. Per questo si tratta di opere incomparabili con quelle dei tanti studiosi stranieri che si sono addentrati nelle ricostruzioni, e accendono anche la speranza che in Cina la memoria storica continui ad essere preservata, nonostante le tante cancellazioni e falsificazioni.
Molti spazi si sono chiusi da quando il giornalista cinese è riuscito a pubblicare nel 2008 il suo primo studio-inchiesta ad Hong Kong (2008) w poi il voluminoso saggio sulla Rivoluzione culturale (2016): Hong Kong non è più il luogo della libertà di espressione e stampa che riusciva ad essere, offrendo una valvola di sfogo alla Cina continentale, mentre gli spazi di ricerca e consultazione di archivi si sono grandemente ridotti. La narrazione storica è sotto rigido controllo, altro che “politically correct”! Perfino ilo scrittore premio Nobel Mo Yan comincia a subire attacchi in rete e minacce di causa per denigrazione dei “martiri della Rivoluzione” (una recente legge apposita) per aver descritto realisticamente personaggi della guerra antigiapponese o della guerra civile, smitizzando le eroicizzazioni. Era già capitato alla scrittrice Fangfang, bollata prima per il suo romanzo sulle vicende della riforma agraria Sepoltura soffice, e più di recente per il diario della pandemia a Wuhan.
Sappiamo comunque da resoconti dell’epoca della Rivoluzione culturale che i materiali proibiti continuavano a circolare in Cina nonostante la censura e i controlli vessatori, e dunque ci auguriamo che le opere di Yang continuino ad alimentare la memoria.
Il lettore non deve farsi spaventare della mole del volume, e può consolarsi sapendo che si tratta di una versione sintetica, approntata con il consenso dell’autore per la diffusione all’estero. I due volumi cinesi erano ben più lunghi, perché frutto di una meticolosa indagine in alcune province colpite dalla Grande carestia seguita al Grande balzo in avanti, senza la quale le considerazioni più generali introduttive e conclusive perderebbero di sostanza: una immersione, uno sprofondare nella tragedia quotidiana di milioni di contadini affamati, scandita dalle decisioni dall’alto ripercosse ancora più rigidamente a livello di base.
E l’indagine del cronista-storico parte dall’impulso di rendere omaggio al proprio padre, perito in quella tragedia, mentre il figlio giovane continuava a credere negli slogan utopistici di mobilitazione e ad avere la vista accecata dalla propaganda ideologica che gli impediva di vedere la realtà. Yang racconta del proprio ritorno a casa, ad assistere il padre morente di fame alla fine di aprile del 1959, e di aver pensato che si trattasse di una sventura familiare, limitata al suo villaggio, da considerare come sacrificio del proprio “piccolo io” in nome del “grande io” collettivo. Gli ci vorranno anni, l’esperienza della Rivoluzione culturale e poi il periodo di “apertura e riforme” stroncato dal massacro di Tian’anmen per aprire gli occhi e per mettere la propria penna di giornalista dell’Agenzia Nuova Cina al servizio della ricerca della verità. La fusione tra vicenda individuale e collettiva ne fa un libro empatico e appassionante, di grande qualità letteraria, en resa dalla traduttrice.
La lapide per il padre e per i milioni di morti della Grande carestia è anche una lapide che l’autore vuole erigere contro il totalitarismo “affinché le future generazioni sappiano che in un certo Paese e in un determinato periodo della storia della società umana, un governo fondato nel nome della “liberazione dell’intera umanità” ha ridotto in schiavitù il suo stesso popolo. La «strada per il paradiso» che quel sistema proclamava e perseguiva è stata di fatto una strada verso la morte”.
Nel capitolo 15 su Le cause fondamentali della Grande carestia, l’autore solleva alcuni quesiti di fondo sul perché menzogne assurde non furono denunciate da nessuno e su come è stato possibile tenere nascosto per mezzo secolo lo sterminio di decine di milioni di persone a causa della denutrizione.
Da una parte nella sua stessa ricostruzione non manca di dedicare un capitolo alla conferenza di Lushan, durata dal luglio all’agosto del 1959, in cui Peng Dehuai coraggiosamente allertò sui sintomi già evidenti di possibili catastrofi derivanti dalla accelerata industrializzazione e creazione delle Comuni popolari. È una lettura avvincente di uno scontro all’interno del gruppo dirigente del Partito comunista cinese, tutto radunato per settimane a convivere come ai tempi di Yan’an (ma non più nelle grotte), con continui colpi di scena e cambi di schieramento da cui Mao esce vincente nel perseguimento della sua utopia e mette con le spalle al muro il grande generale, abbandonato dai più.
Dall’altra la spiegazione sta nella mancanza di correttivi di un sistema totalitario che combina il dispotismo imperiale tradizionale della Cina con il sistema di potere bolscevico di Lenin e Stalin. E se gli imperatori potevano dire come luigi XIV “lo Stato sino io”, Mao poteva dichiarare “la società sono io”, talmente pervasivo era il dominio del Partito e dell’ideologia.
Nelle conclusioni (e non dimentichiamoci che il libro è datato e la versione per l’estero risale a più di dieci anni fa), l’autore si dice fiducioso sull’avvento della democrazia in Cina, ma è assai cauto e prudente, forse avendo assistito all’esito di Tian’anmen:
Secondo lui “ci vorrà molto tempo” e la “trasformazione del sistema politico non deve essere troppo radicale e affrettata:
“Nell’ultimo secolo il popolo cinese ha subito fin troppe perdite a causa del radicalismo e ha imparato la lezione: un approccio radicale può gettare la società nel caos. Se le azioni drastiche dei democratici radicali e degli anarchici fanno perdere a un regime debole la capacità di controllare la società, gli autocratici ne approfitteranno, perché la dittatura è il mezzo più efficace per porre fine al disordine sociale e stabilire un nuovo ordine. Coloro che tra il popolo non sopportano l’anarchia accoglierebbero un dittatore come un salvatore. Quindi, chi si oppone al sistema autocratico in modo eccessivamente drastico e frettoloso piò sortire il risultato opposto, facilitando l’ascesa di una nuova dittatura”.