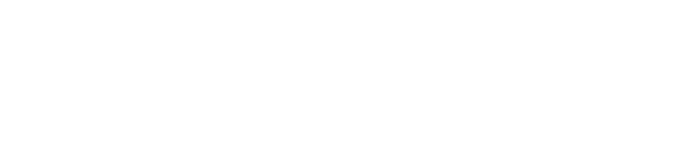Piero Calamandrei e il mondo dell’avvocatura: l’intervento di Silvia Calamandrei ad Arezzo il 29 novembre 2019
Arezzo 29 novembre 2019
Intervento Silvia Calamandrei – Convegno di formazione
Grazie di avermi invitato a questo evento formativo e di darmi l’opportunità di ricordare Piero Calamandrei come avvocato: dunque non solo come costituzionalista e giurista, oltre che come eccezionale testimone del Novecento nei suoi epistolari e diari e commentatore della rinascita italiana nel dopoguerra dalla rivista “Il Ponte”. Un padre della Repubblica che è stato giovane giurista ed avvocato e che già nella fase giovanile si era molto impegnato per la riforma della giustizia.
Il titolo che avete voluto dare, sulla eredità ancora viva del suo pensiero, mi si è confermato in questa intensa settimana, che ha visto mercoledì 27 una presentazione alla Camera dei deputati, alla presenza del Presidente della repubblica, della edizione in open access delle sue opere giuridiche, i dieci densi volumi curati dall’allievo Mauro Cappelletti. Il giorno stesso a Siena, un convegno dedicato alla sua figura, nel centenario della sua chiamata alla cattedra nella Facoltà di Giurisprudenza, ha approfondito vari aspetti della sua opera, con una tavola rotonda che ha avuto come oggetto una recente edizione del Mulino sul suo contributo al codice di procedura civile del 1940.
Il Primo processo nella grande Guerra ed un pamphlet giovanile. Troppi avvocati
In occasione del centenario della Grande Guerra è stato ristampata in prezioso volumetto[1] la rievocazione del primo processo che Piero Calamandrei affrontò come avvocato, una difesa di soldati accusati di diserzione, ai quali riuscì ad evitare la condanna invocando questioni procedurali. Ẻ un episodio che rievoca negli anni Cinquanta sul “Ponte”, in una meditazione sulla guerra che è ormai ben lontana dagli entusiasmi giovanili di interventista democratico.
Va anche ricordato che uno dei primi scritti divulgativi di Calamandrei, per le edizioni de La Voce dirette da Prezzolini, fu nel 1921 il pamphlet Troppi avvocati, che conosce ancora riedizioni [2]tanto conserva attualità nella disamina della professione forense in Italia.
Saggio documentale e di intervento attivo nel dibattito del tempo, il libro ha un sapore ben diverso dal più famoso Elogio dei giudici, che ha avuto fortunata circolazione negli ultimi decenni, in connessione con il dibattito sul ruolo della magistratura. Vi si ritrova però la stessa convinzione della indispensabile quotidiana interlocuzione tra giudici e avvocati, “la inesorabile complementarità, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni”.[3]
Agli inizi del 1920 Calamandrei, trentenne, è professore di procedura civile e ordinamento giudiziario all’Università di Siena, e già nella prolusione al suo corso, abborda le tematiche che saranno più approfonditamente trattate nell’operetta del 1921. E più politicamente le tratta in un intervento del giugno 1920 al Convegno del Movimento di rinnovamento nazionale, dal titolo “Il problema giudiziario”. Il tema della professione forense si inquadra nella tematica della riforma della procedura civile, dell’ordinamento giudiziario, e del sistema d’istruzione.
Nel saggio di Calamandrei vengono sviluppate più ampiamente le tesi già formulate nella prolusione del 16 gennaio 1920 a Siena, intitolata L’avvocatura e la riforma del processo civile[4].
Il nodo è il carattere privatistico o pubblicistico del processo civile, tema su cui Calamandrei continuerà ad elaborare fino alla riforma dei codici dei primi anni Quaranta e alla difesa del Codice di procedura civile negli anni del secondo dopoguerra.
Sulla scia dell’insegnamento di Chiovenda, Calamandrei è chiaramente per la moderna opzione pubblicistica, contro l’approccio tradizionale privatistico del codice del 1856, secondo cui lo Stato si mantiene estraneo ai conflitti di interessi che possano sorgere tra i singoli, ed il giudice è mero spettatore passivo della contesa tra le parti.
Secondo Calamandrei, nella concezione pubblicistica il giudice diviene il “personaggio centrale del dramma giudiziario” e il perno del processo appare l’utilità collettiva. Di conseguenza cambia anche la funzione dell’avvocato. Se nel primo caso a prevalere è la più accorta tattica avvocatesca, e dunque l'”avvocato azzeccagarbugli”, nel secondo la funzione dell’avvocato assume carattere pubblico, ed egli diventa il miglior collaboratore del giudice al raggiungimento del “vero giuridico”: “l’avvocatura appare pertanto quale elemento integrante dell’ordinamento giudiziario” e l’avvocato è il “sacerdote esemplare” della “religione del giusto”, mettendo la sua professionalità al servizio di una giusta sentenza.
“L’avvocato appare […] come un elemento integrante dell’ordinamento giudiziario, come un organo intermedio, posto tra il giudice e la parte, nel quale l’interesse privato ad avere una sentenza favorevole e l’interesse pubblico ad avere una sentenza giusta si incontrano e si conciliano”.
Nel secondo dopoguerra, quando è tra Presidente del CNF, Calamandrei torna su questi temi richiamandosi all’insegnamento di Chiovenda e difendendo il proprio operato[5], in particolare in relazione con la collaborazione con il Guardasigilli Grandi, nella elaborazione del Codice di procedura civile, insieme a Carnelutti e Redenti, tutti seguaci della scuola giuridica di Chiovenda e notoriamente non fascisti.
La collaborazione al Codice di procedura civile
Ampio materiale su questa collaborazione è offerto da Calamandrei stesso, nel suo Diario1939-1945,[6]di cui è stata pubblicata l’edizione integrale ricostruita sul manoscritto conservato nell’archivio di Montepulciano. Tale archivio, che si affianca ad un archivio storico che documenta un tribunale operante fin dal XIV secolo, custodisce anche appunti, materiali preparatori e corrispondenze in merito al Codice[7], ivi compresa la relazione di presentazione al Re.
Ẻ questo materiale che ha fatto oggetto di studio e commento nel volume del Mulino, curato da me assieme a Guido Alpa, che contiene, oltre a contributi di giuristi quali Alpa e Consolo, un significativo saggio storico di Guido Melis ad Antonella Meniconi.
Il primo cenno nel Diario alla cooperazione ai Codici è del 30 novembre del 1939, poco dopo l’inizio della guerra. L’avvocato Alessandro Levi gli racconta che “quando qualcuno propose a Grandi di chiamare a cooperare al Codice di Procedura Civile anche me, avvertendo però che io non ho tessera, Grandi avrebbe detto: non cerco tessere, cerco cervelli”. La versione del Codice di procedura civile preparata dal precedente ministro Solmi, sbilanciata verso le concezioni germaniche del diritto, era stata criticata su riviste giuridiche proprio da Calamandrei, Redenti e Carnelutti, che Grandi convoca per una revisione di tale approccio.
Ẻ Grandi stesso, nel 1983[8], a sottolineare le difficoltà incontrate nella riforma dei codici, a causa dell’accordo sottoscritto tra governo nazista e governo fascista che impegnava alla formulazione su basi comuni del codice civile, del codice di procedura civile e del codice della navigazione, e a rivendicare la sua difesa del diritto romano. Ricorda altresì come nel lasciare l’Italia, il 18 agosto 1943, avesse affidato a Calamandrei, con una lettera, “la difesa del nostro Codice di procedura civile che è in massima parte opera tua. Non si tratta di Codice fascista, ma bensí di codice degli italiani”. Un’altra lettera, custodita tra le carte di Calamandrei e datata 4 agosto, ha contenuto più o meno analogo.
Calamandrei, sosterrà in effetti nel dopoguerra essersi trattata di collaborazione strettamente tecnica. Confermava così quanto aveva scritto nel diario il 14 marzo 1940, quando l’amico Sandro Policreti lo aveva rimproverato per la sua collaborazione a far fare bella figura a un ministro fascista:
“Non ha tutti i torti: ma potrei decentemente sottrarmi a questa consulenza tecnica se può servire a dare agli italiani un codice migliore?”. Nelle due lettere del dopoguerra Calamandrei ricostruisce dettagliatamente la collaborazione col Ministro fascista e sostiene di aver accettato l’invito del 1939 ad una consulenza “per il dovere di non rifiutare l’opera mia a una legge che non era espressione di un regime, ma di un cinquantennio di studi e che per questo si prevedeva destinata a sopravvivere al fascismo, ed anche un po’ per il gusto polemico di sottolineare che il fascismo quando aveva bisogno di studiosi seri, doveva andare a mendicarli tra gli antifascisti”.
C’è chi ha giudicato riduttiva la giustificazione della collaborazione “tecnica” ai Codici. Tra questi il giurista Franco Cipriani e lo storico Sergio Luzzatto. Il commento non è nuovo e Calamandrei già se lo era sentito rivolgere in una garbata lettera di Leone Ginzburg dal confino di Pizzoli, in data 1° gennaio 1942, con grande finezza argomentativa, in riferimento al “bel saggio sul nuovo processo civile e la scienza giuridica” che C. aveva appena pubblicato sulla “Rivista di diritto processuale civile”. Ginzburg scrive che la lettura gli ha fatto “trascorrere un’ora deliziosa, un po’ a darle ragione, un po’ a compiacermi della nettezza con cui ella esponeva gli argomenti che non condividevo”[9].
Ecco il punto di vista di Ginzburg, che con rispetto per la scelta di Calamandrei va alla sostanza della questione:
“Le mie obiezioni non sono certo di natura teoretica, ma pratica. Ritengo cioé che la pura tecnica giuridica, di là dai valori etico-politici, esista solo nei gradini più bassi: riscattata, dal punto di vista etico, dai concreti casi cui di continuo si applica. Più si sale, e meno è possibile che l’atto tecnico rimanga puramente tecnico, non si colori cioé di qualche cos’altro. Ragionando diversamente si viene a negare la maggiore importanza e il maggior raggio d’azione delle personalità più eminenti e il vario significato che la loro opera può assumere. Che lei sia convinto della sua tesi, se n’è avuta prova tangibile e, starei quasi per dire, clamorosa; che senza alcun dubbio sarebbe mancata ove ella fosse stata d’un’altra opinione; ma voglio vedere se, il giorno che per avventura le capiti di riesaminare storicamente la tesi teorica da lei esposta e l’esperienza concreta che n’è derivata, non scorgerà in una luce di maggior concretezza anche la figura del puro tecnico, quando la sua azione di tecnico abbia una portata veramente generale“.
Va osservato che uno storico del diritto come Carlo Ghisalberti, in La codificazione del diritto in Italia (Laterza, Bari, 1985), tenendo ben presente il dibattito apertosi dopo la caduta del fascismo, scrive che il codice del 1942, grazie all’opera di Carnelutti, Redenti e Calamandrei, “nel suo tecnicismo formalistico, proprio della migliore tradizione in materia, finiva con l’accentuare il contenuto pubblicistico del giudizio civile, elevando il ruolo del giudice e attribuendo un maggiore spazio al pubblico ministero nelle sue diverse fasi, apparentemente in ossequio alle direttive statualistiche del regime ma, in realtà, nel tentativo di razionalizzare autoritativamente il processo accelerandone i tempi di svolgimento e migliorandone le modalità”.
Ẻ opportuno ricordare anche quanto Calamandrei argomenta egli stesso al riguardo nella già citata commemorazione del 1947 di Chiovenda, con una chiarezza che rende la materia comprensibile anche ai non specialisti.
Calamandrei entra nel merito definendolo “un codice antitotalitario”, non solo perché vi collaborarono studiosi antifascisti, “ma soprattutto perché la sostanza del Codice era un’energica reazione contro quello slittamento della giustizia verso la giurisdizione volontaria e verso l’illegalismo poliziesco e paternalistico che in quegli stessi anni si compieva metodicamente in Germania”. Per C. il succo della concezione chiovendiana, rispecchiata nel codice, è “nella relazione mediatrice di reciprocità complementare tra l’idea individuale e l’idea sociale, tra il diritto soggettivo e l’esigenza collettiva di giustizia, […]che corrisponde ad una tendenza storica positiva, viva ed operante in questo secolo in tutte le legislazioni democratiche dell’Europa occidentale”
E aggiunge:
“Ogni intervento dello Stato volto a regolare o a limitare l’iniziativa privata per considerazioni di ordine sociale ed a coordinare l’interesse privato colle ragioni dell’interesse collettivo, sarebbe, secondo essi, “fascismo”: e per questo sono tratti a considerare come espressioni di “fascismo” nella procedura civile tutte quelle norme che danno al giudice i poteri indispensabili per ricercar la verità e per impedire che il processo si trasformi in uno strumento della malafede del litigante più scaltro o più ricco, a danno del più povero o del più onesto”.
Costoro non si accorgono, secondo C., “che “autoritario può dirsi solo lo Stato nelle quali le leggi sono imposte autocraticamente dall’alto e non deliberate da organi rappresentativi, ma che anche negli stati tradizionalmente liberali e democratici nessuno ha mai pensato che sia espressione di “autoritarismo”, inconciliabile colla democrazia e colla libertà, l’attribuzione al giudice dell’autorità necessaria per far osservare, anche contro la volontà e contro l’interesse individuale, le leggi approvate dagli organi eletti dal popolo”.
Queste argomentazioni del 1947 vanno lette alla luce del contributo del costituente e del giurista sul nesso tra diritti di libertà e diritti sociali: Calamandrei misura il merito del Codice in base all’impianto dei diritti e dei doveri della nuova Italia democratica in costruzione.
Avvocati e antifascismo
L’impegno di Calamandrei come avvocato e presidente del CNF è stato negli anni recenti particolarmente valorizzato dal Professor Guido Alpa, nella sua funzione di Presidente del CNF. Oltre ad avergli voluto dedicare nel 2013 una mostra biografica e bibliografica a Roma, il Presidente Alpa mi ha chiesto in occasione del Settantesimo della Liberazione di ricordarlonella riflessione sul ruolo degli avvocati nell’antifascismo, avviata al Primo Congresso del Consiglio nazionale forense, con la commemorazione dell’avvocato Bocci alla presenza del Presidente Enrico De Nicola, “avvocato tra gli avvocati”, “a significare …che veramente justitia est fundamentum reipublicae“.
Quando pronuncia il suo discorso nel 1947 nella sala dei Cinquecento Calamandrei è animato da speranza nella nuova democrazia in costruzione, ma anche da mestizia e ansietà. Rievoca i nomi degli avvocati caduti per la libertà, traendo ispirazione perché la toga sia “veste simbolica del coraggio civile, dell’altruismo e della solidarietà umana”.
Nella meditazione sul martirio e la tortura di Bocci Piero Calamandrei sembra proseguire un ragionamento che aveva fatto nel momento più drammatico del fascismo e della guerra, quando a Firenze, nella sede dell’Azione cattolica, aveva tenuto la sua conferenza Fede nel diritto,ritrovata tra le carte d’archivio riordinate a Montepulciano ed edita nel 2008 da Laterza con autorevoli prefazioni di Gudo Alpa, Pietro Rescigno e Gustavo Zagrebelsky.
Nel momento più buio, nel gennaio 1940, quando il diritto viene calpestato dovunque in Europa, Calamandrei aveva riaffermato la sua fede nella certezza del diritto e nel principio di legalità, contro le teorie totalitarie del “diritto libero”. C’è stato nel frattempo un baratro, un precipizio della civiltà, un crollo della giustizia, della legalità, della santità delle leggi, e i mostri sono ancora in agguato.
Ẻ una interrogazione ansiosa:
“E allora che cosa dobbiamo fare noi giuristi? Dobbiamo metterci di nuovo a tirar su i nostri castelli di leggi, come le formiche che dopo ogni passaggio di piede si rimettono a scavare il loro formicaio proprio in mezzo al sentiero? Oppure dobbiamo proclamare, sinceramente e disperatamente, il fallimento e l’inutilità del diritto?”.
La lezione dei “nostri morti”, di coloro che hanno dato la vita per la giustizia come Enrico Bocci, è che bisogna difendere la legalità, ma “la legalità non è tutto”, non basta più dopo le camere a gas:
“Al disopra e al didentro delle leggi scritte, di cui noi siamo i custodi e gli interpreti, ci occorrono quelle leggi non scritte di cui parlava Antigone, quella legge di cui parlava prima di morire Cino da Pistoia, nostro confratello, “che scritta in cuor si porta”.
Sono “quelle leggi più profonde che ci parlano dentro, “che dal didentro ci suggeriscono, qualunque sia l’articolo che troviamo scritto nei codici esterni, l’amore per la libertà, la ribellione alla prepotenza e al privilegio, la solidarietà coll’innocenza, la fratellanza verso tutti gli uomini, di tutte le razze e di tutti i continenti, che lavorano e vogliono la pace”.
Queste leggi non scritte verranno invocate anche nell’ultima arringa, in difesa di Danilo Dolci, nel 1956, ma con uno sviluppo ulteriore, il riferimento alla Costituzione, che nel 1947 si stava scrivendo. Ẻ un percorso, quello del giurista, dell’avvocato e del costituzionalista Calamandrei, che si nutre dell’esperienza storica per consolidare la sua fede nella giustizia.
Il ricordo di Enrico Bocci , soprannominato “Placido” fin dal suo impegno clandestino negli anni Venti assieme ai Rosselli, Ernesto Rossi e Salvemini nel “Non mollare”, si congiunge nel discorso con quello di altre figure eminenti di avvocati impegnati attivamente nella Resistenza e che si sono sacrificati per gli ideali di giustizia e libertà: dai piemontesi Duccio Galimberti e Renato Martorelli, al bolognese Mario Jacchia. E Calamandrei legge di fronte ai colleghi i nomi dei tanti avvocati caduti, delle “toghe lacerate dalla mitraglia”.
Altri martiri tra gli avvocati Calamandrei rievoca a Ferrara in un discorso del 1950; tra gli undici caduti della strage della notte del 15 novembre 1943 tre erano avvocati Giulio Piazzi, Ugo Teglio, Mario Zanatta. E nell’occasione sviluppa un discorso sull’avvocatura come “la naturale e temuta avversaria di tutte le tirannie” che “non poteva non essere la fiera nemica, sospettata e ricambiata d’odio, dal fascismo”. Sotto il fascismo “di tutti i professionisti, quelli che più fecero a gara con gli operai e con gli studenti a sfidare confini e prigionie e i rigori del Tribunale speciale e le rappresaglie e le spedizioni punitive, furono gli avvocati”. E le prime spedizioni punitive incendiavano di pari camere del lavoro e studi di avvocati, “sventolando come trofei bandiere rosse e residui abbruciacchiati di carta bollata”. La toga fa paura ai tiranni, perché è uno “schermo più solido di una corazza contro tutte le ingiustizie e contro tutte le soperchierie”.
Nell’immediato dopoguerra Calamandrei riflette sugli anni bui del fascismo al potere e della guerra civile per gettare luce sull’esperienza specifica dei giuristi, avvocati e giudici, commemorando figure di avvocati e giudici che forse non sono stati in prima linea, ma si sono trovati tra i
“condannati, durante vent’anni, ma specialmente durante gli ultimi cinque (quelli per intenderci delle persecuzioni razziali), a studiare e ad applicare leggi di cui sentivamo il ribrezzo, come si prova al contatto di una materia immonda”.
Calamandrei parla in prima persona, perché parla anche di se stesso. Sentiamo vibrare accenti autobiografici quando ricorda nella commemorazione di Vittorio Emanuele Orlando (31 gennaio 1953 – Consiglio ordine avvocati di Roma) come l’insigne giurista, dopo la rinuncia al Parlamento e all’Università, avesse trovato “soltanto nella toga” la libertà che non c’era più altrove:
“Vittorio Emanuele Orlando sentì in quegli anni quello che ciascuno di noi avvocati, ognuno nella sua cerchia tanto più modesta, ha sempre trovato nei momenti, che tutti abbiamo conosciuti, di debolezza e di viltà: che basta indossare la toga, questa dimessa veste che al pari dell’abito di una regola religiosa è il segno dell’altruismo, per sentir vinte tutte le esitazioni, e scacciate tutte le viltà e messi da parte tutti gli egoismi e tutti i conformismi”.
E ancora dal medesimo discorso:
“Basta indossare la toga per respirare aria di libertà e di dignità umana: questo poco spazio che è delimitato dalla toga intorno al cuore dell’avvocato, è anche in tempi di tirannia l’estremo rifugio entro cui gli oppressori non riescono ad irrompere: intorno all’avvocato in toga c’è un cerchio magico contro il quale si infrangono tutte le malie della intimidazione e della corruzione”.
Legalità e democrazia
Per tornare all’epoca del fascismo, e alla tenacia con cui Calamandrei aveva coltivato la tematica della legalità, anche nei momenti di più cupa disperazione, si può citare il suo discorso agli universitari fiorentini del gennaio 1940 intitolato alla Fede nel diritto:
Non lasciatevi dunque scoraggiare o giovani che vi accingete agli studi giuridici. A voi è riservato nella società il grande ufficio di ricordare ai profani che gli istituti attraverso i quali il diritto viva, il rispetto delle leggi, il prestigio degli avvocati, la indipendenza dei giudici non sono questioni di pura tecnica, “cabale dei giuristi” come si dice, ma sono condizioni essenziali della vita individuale, alle quali è attaccata direttamente la sorte di ognuno. Voi sapete di quel contadino imbarcato per l’America che dormiva durante la tempesta e che al compagno impaurito che lo svegliò per dirgli che il bastimento andava a fondo, rispose tra il sonno: “Che vuoi che me ne importi, il bastimento non è mica mio!”. Ma il bastimento è di tutti, o signori, quando si tratta del diritto: perché su questo bastimento del diritto sono imbarcati la dignità e le speranze, l’onore e la vita di ciascuno di noi. Dunque apprestarsi ad esser tra gli uomini i predicatori di queste leggi, dedicar la propria vita a risvegliar nelle coscienze il senso dell’importanza del diritto e lo stimolo all’operare che da esso deriva, non vuol dire isolarsi in una vuota tecnica avulsa dalla realtà storica: vuol dire anzi difendere, attraverso il rispetto delle leggi uguali per tutti, quella consapevolezza della uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi allo spirito, che è, per chi ascolti la storia, la conquista più alta, e meno rinunciabile, della nostra civiltà cristiana.
Il baluardo della legge uguale per tutti, frontiera minimale su cui attestarsi contro la tirannia, sul quale poi la riflessione di Calamandrei proseguirà negli Appunti sulla legalità, scritti nell’esilio umbro dell’inverno 43-44 e completati nella Firenze liberata dell’estate del 1944.
Questi scritti sono stati recentemente editi da Laterza con il titolo Non c’è libertà senza legalità e Il fascismo come regime della menzogna, quest’ultimo una disamina a caldo della patologia giuridica del fascismo e dei tratti essenziali del regime, sulle cui rovine costruire la nuova legalità democratica. Con essi si apre la fase del Calamandrei costituente e costituzionalista, che però non rinuncerà mai alla toga di avvocato, “contro le ingiustizie e le soperchierie”, pronunciando arringhe memorabili come quella contro Anfuso in difesa dei Rosselli o l’ultima in difesa di Danilo Dolci.
Paradossalmente, nell’ultimo decennio Calamandrei è stato più indagato dagli storici della politica e della letteratura che dai giuristi, integrando la sua poliedrica figura con le componenti dell’impegno civile e giornalistico, della scrittura letteraria e della pittura e fotografia[10]. Nel volume Codici e rose, curato dalla studiosa ferrarese Paola Roncarati e da Rossella Marcucci, botanica padovana, sono state evidenziate anche le sue doti precoci di naturalista, editando e commentando per la Olschki il suo erbario di adolescente, conservato nell’Istituto storico della Resistenza Toscana a Firenze[11].
Se il Diario era destinato agli storici futuri, a testimonianza di una civiltà minacciata di estinzione, l’erbario invece, testimonianza di un ciclo di fioritura dalla primavera all’ autunno del 1904, in piena adolescenza, Piero avrebbe voluto portarlo con sé, come viatico nell’al di là, tornando alla terra dei progenitori etruschi. I tanti segni, le tante impronte lasciate, soprattutto attraverso la scrittura, saggistica, poetica, letteraria e l’oratoria giuridica e politica, contavano forse meno per luidi queste creature vegetali conservate amorosamente, alcune delle qual emanano ancora una vaga fragranza.
Ma forse tutto si tiene: mettere le etichette alle piante, classificarle per specie con il nome latino e volgare, indicare il luogo dove sono state colte, fissarle delicatamente alla pagina, è un’operazione che ricorda anche quella dell’archiviazione di un fascicolo, di un caso vivente sottoposto alla scienza giuridica, di una vicenda umana da classificare sotto la fattispecie legale. Rigore scientifico classificatorio, aderenza alla legge, ma libertà dello spirito interpretativo, che cum-patisce nel difendere una causa e nel giudicare: il codice e la rosa, come nel logo dell’avvocato Piero Calamandrei.
Tornando alla edizione in open access delle Opere giuridiche, di cui mi rallegro perché consente a tanti studiosi, giuristi e non, di accedere al corpus più significativo dal punto di vista accademico e professionale, voglio sottolineare che la presenza in rete delle citazioni di Calamandrei, ed in particolare del suo discorso agli studenti sulla Costituzione (1955) e degli interventi in difesa della scuola pubblica e della sua funzione di formazione dei cittadini, era già particolarmente significativa. Questo testimonia della vitalità del suo pensiero, che continua a circolare anche tra i giovani, a nutrirne l’educazione alla partecipazione democratica. Tanti sono i video prodotti dagli studenti stessi a commentare quelle parole, e di recente ne sta circolando uno nelle scuole, prodotto dal Centro Calamandrei di Iesi intitolata Alla fine della nuvola, che affronta tematiche di grande attualità come quelle dell’accoglienza e della solidarietà, ispirandosi all’utopismo di Calamandrei e alla sua arringa in difesa di Danilo Dolci.
Come scriveva il suo biografo Alessandro Galante Garrone:
L’importante è continuare a camminare, per la strada da lui additata, senza domandarci, inquieti, se si tratti di ideali realizzabili o di iridescenti utopie, o di qualcosa di indistinto e brumoso fra gli uni e le altre; se le vittorie sperate verranno davvero, e quando. «La funzione delle utopie, la funzione degli ideali verso i quali ci si dirige come verso l’arcobaleno che è là alla fine della nuvola, sull’orizzonte, è proprio questa: di aiutarci a camminare in questo duro passaggio attraverso la vita, pur sapendo che quando si arriverà là dove si credeva fosse l’arcobaleno, ritroveremo soltanto un po’ di nebbia; ma l’arcobaleno sarà ancora più in là, e noi continueremo ad inseguirlo senza fermarci». Sono, anche queste, parole sue.
[1] Edizioni Henry Beyle, Milano 2014.
[2]Piero Calamandrei, Troppi avvocati, ristampa anastatica dell’opera del 1921 con introduzione di Silvia Calamandrei, Fondazione Forense Bolognese, Bologna 2006.
[3] Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Prefazione alla II edizione, Ponte alle grazie,1989,, pag. XXIV.
[4] Piero Calamandrei, Opere giuridiche, Vol. II, Morano, Napoli 1966, pag. 12 e segg.
[5]Commemorazione di Chiovenda in Piero Calamandrei, Opere giuridiche, Volume X, pag. 261, Morano, Napoli.
[6] Edizione integrale edita dalle Edizioni di storia e letteratura nel 2015 con introduzione di Mario Isnenghi.
[7] Cfr. Archivio Piero Calamandrei, Inventario, a cura di Francesca Cenni, Siena 2015, pp. 62-69.
[8] Dino Grandi, 25 luglio 1943, a cura di Renzo De Felice, Il Mulino, Bologna 1983.
[9] In Lettere dal confino 1940-1943, a cura di Luisa Mangoni, Einaudi, Torino 2004, ora riprodotta anche nel volume del Mulino.
[10] Su Calamandrei fotografo nella Grande Guerra cfr. Silvia Bertolotti, Contrasti, Fondazione del Museo di Trento, 2017.
[11] Paola Roncarati e Rossella Marcucci, Codici e rose, Olschki, Firenze 2015.