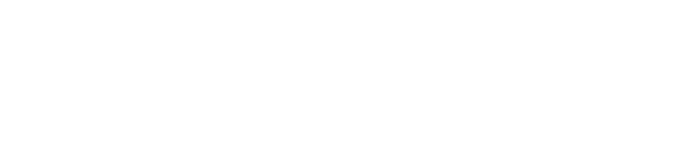ELIO BERNABEI
Riceviamo da Armando Bussi, un ricercatore nostro amico, un utile e interessante testo su Elio Bernabei, che va a colmare una lacuna nella documentazione sulla storia recente di Montepulciano. Infatti Elio Bernabei, pur noto a tutti perchè a lui sono intitolate una strada importante della prima periferia di Montepulciano e la Casa di riposo poliziana “Cocconi – Bernabei”, in realtà è sostanzialmente sconosciuto. La ricerca di Armando Bussi, accuratamente documentata, non solo riempie un vuoto, ma è anche un esempio di studio, a cui si può ispirare chiunque chi voglia seriamente approfondire le vicende storiche pur senza essere uno studioso di professione. Il nostro amicoi ci ha inoltre gentilmente fornito anche la riproduzione di molto del materiale da lui consultato, che rimane presso la Biblioteca a disposizione di chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento, e che contiamo di mettere presto online in modo organico.
ELIO BERNABEI
di Armando BUSSI
Nell’ultimo periodo della seconda guerra mondiale – quando, fra il settembre 1943 e l’aprile 1945, parte dell’Italia venne occupata dai tedeschi – un evento particolarmente cruento fu la rappresaglia attuata dai nazisti dentro una cava di pozzolana vicino Roma (poi chiamata Fosse Ardeatine) in cui perirono 335 ostaggi; non solo romani e laziali, ma anche di altre regioni. Undici di essi erano di varie parti della Toscana. Dalle provincie costiere venivano Lido Duranti di Castelfranco di Sotto, Odoardo Della Torre e Umberto Lusena di Livorno, Sestilio Ninci di Cecina, Ilario Zambelli di Rio nell’Elba ed Ezio Lombardi di Sorano; dalla Garfagnana Paolo Angelini di Castelnuovo; da Pistoia Francesco Ciavarella; da Arezzo Mario Magri; dal senese Francesco Savelli di Asciano ed Elio Bernabei di Montepulciano[1].
Quella dei Bernabei era un’antica famiglia poliziana. Le prime notizie su di essa risalgono a metà del Settecento, quando sappiamo che venne al mondo Domenico figlio di Angiolo e nipote di Pollonio; da Domenico nacque poi Angiolo, da lui Ferdinando, padre a sua volta di Quintiliano (da notare come, nella città del Poliziano, ricorrano ben due Angiolo, nome di battesimo del grande umanista quattrocentesco). Questo Quintiliano, venuto alla luce nel 1846[2], è quasi certamente quel “Capitano Bernabei” di cui parlano alcune cronache, narrando che combatté valorosamente nella sfortunata campagna dell’Agro Romano del 1867 – guidata da Giuseppe Garibaldi allo scopo di riunire la Roma pontificia all’Italia nata sei anni prima – conclusasi con la sconfitta di Mentana[3]. Quintiliano e sua moglie Agnese ebbero molti figli; dal più giovane – Giotto, classe 1893 – discenderà il ramo della famiglia tuttora esistente, a Firenze. Il primogenito – Corrado, nato nel 1874 – si sposò con Concetta Sonnini, di una famiglia benestante di Montepulciano; ebbero tre figli, due femmine – Lelia ed Elsa, morte da piccole – e un maschio, appunto Elio, la cui storia vogliamo qui raccontare.
Nasce il 29 settembre 1907; è un ragazzo tranquillo e riflessivo, che a scuola studia con impegno; inoltre è appassionato di musica, gli piace suonare il violino e vi si applica con determinazione[4]. Terminate le superiori, lascia la Toscana per andare a studiare al Politecnico di Torino, ospite di un amico, Angiolo Del Corto[5]; il 13 novembre 1929 si laurea in Ingegneria industriale chimica; subito dopo supera gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Elio nel 1930 frequenta il corso Allievi Ufficiali di complemento di Pola; al termine della ferma è inviato in congedo come Sottotenente di Artiglieria. Trova presto lavoro nelle Marche, per l’anno scolastico 1932/1933, come insegnante nel Regio Istituto Industriale Nazionale di Fermo; poi nello stesso 1932 partecipa a un primo concorso alle Ferrovie dello Stato, riservato agli Ingegneri chimici, dove però non supera la prova orale. Ma – presumibilmente – la Commissione d’esame è stata troppo severa e i posti non sono stati coperti, perché a gennaio 1933 è bandito un nuovo concorso a tre posti, e il Bernabei stavolta si classifica primo[6].
A maggio l’Ufficio Sanitario FS lo sottopone a visita medica: è alto m.1,63 e di sana e robusta costituzione fisica (nonostante un lieve strabismo); viene quindi dichiarato idoneo al servizio[7].
Il 7 agosto 1933 è assunto con la qualifica di Allievo Ispettore ed assegnato a una struttura della Direzione Generale FS, l’Istituto Sperimentale. Tale Istituto si occupa di ricerca, verifiche e consulenze sulle problematiche connesse con l’esercizio ferroviario; ha sede in Roma, in un fabbricato realizzato alla fine dell’Ottocento per la prima Stazione Trastevere, a Piazza Ippolito Nievo 29 (circa a metà della strada allora denominata viale del Re, che poi diverrà appunto viale Trastevere). Bernabei si stabilisce nella Capitale, quartiere Prati, zona Piazza Mazzini: inizialmente in via Sabotino 17[8], poi lì accanto, in via Antonio Baiamonti 2[9].
L’11 agosto 1934, prestato il prescritto giuramento di fedeltà allo Stato italiano, partecipa a Firenze al corso di istruzione per Allievi Ispettori; ha fra i suoi docenti l’ing. Guido Corbellini, dirigente FS e futuro Ministro dei Trasporti, che lo ricorderà come “un promettente cultore della ricerca applicata … di intelligenza versatile e di animo mite … diligente e serio funzionario, da tutti assai stimato”[10]. Il babbo di Elio, Corrado, fa così in tempo ad apprezzare i buoni risultati del figliolo; poi, nel 1935, muore.
Le note informative annuali FS qualificano sempre Bernabei come “ottimo” e il nostro fa rapidamente tutta la carriera consentita dalla normativa dell’epoca (Ispettore di 2° classe, poi di 1° classe; infine, dal 1° gennaio 1942, Ispettore Principale)[11]. Svolge i suoi compiti di ricerca e sperimentazione sia in laboratorio, sia muovendosi in treno per l’Italia. Fa anche parte di una importante associazione tecnico-professionale, il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, ove svolge per un certo periodo funzioni di vicesegretario e viene convinto, vincendone la ritrosia, a pubblicare un decina di studi scientifici sulle sue attività, che riscuotono grande apprezzamento[12]. Insomma, è ben inserito nella vita professionale che ha scelto, dove lo aspetta un probabile futuro da alto dirigente.
Dalle foto appare un bell’uomo, capelli curati, baffetti alla Clark Gable. Non si è ancora sposato e la madre, rimasta vedova, si trasferisce a Roma con lui; ma entrambi tornano spesso a Montepulciano, dove hanno mantenuto la vecchia casa di famiglia in via Roma (attuale via Gracciano nel Corso[13]).
Cresciuto sotto la dittatura di Benito Mussolini, Elio risulta avere fin dal 1928 la tessera del Partito Nazionale Fascista[14]; si dedica però alla lettura di autori del Risorgimento[15], cominciando a maturare in sé l’esigenza di un’Italia diversa; inoltre, è profondamente cristiano. E la sua è una fede attiva, con un gran bisogno di partecipazione: a Montepulciano frequenta l’Azione Cattolica locale, cui è iscritto fin da ragazzo; a Roma fa parte del gruppo romano dei laureati cattolici (ricordiamo che alla presidenza della Federazione Universitaria Cattolica Italiana – F.U.C.I. – arriva nel 1939 Aldo Moro) e lavora nell’organizzazione caritatevole Conferenza di San Vincenzo dei Paoli, con cui si dedica a visite a domicilio ed altre attività di assistenza a famiglie povere (in particolare nella borgata di Primavalle)[16].
Nello stesso 1939 la Germania nazista causa lo scoppio della seconda guerra mondiale con Francia e Inghilterra, conflitto in cui l’Italia entra nel 1940 a fianco dei tedeschi; tutto ciò è vissuto da Bernabei come un’imposizione, contraria agli interessi del nostro Paese; quindi, pur restando formalmente iscritto al P.N.F., sente crescere in sé l’ostilità alla dittatura fascista e un gran desiderio di libertà. Ma ”la libertà e la dignità non devono esserci semplicemente elargite da chi combatte per una stessa idea: dobbiamo guadagnarcele anche noi, se vogliamo che siano veramente nostre”: questo dichiara, durante un lungo viaggio in treno, a un amico, il vecchio socialista Giovanni Mariotti[17]. Come dirà efficacemente, qualche anno dopo, uno scrittore di origini poliziane, “se i cambiamenti dell’esistenza non intervengono da sé bisogna provocarli”[18]; così, anche Elio si prepara a entrare in azione. Continuando a frequentare Montepulciano, intensifica i contatti con antifascisti locali, sia laici che cattolici: fra questi ultimi, molti suoi giovani amici dell’Azione Cattolica e della F.U.C.I., che ruotano intorno al movimento dei “cristiano sociali”[19], fondato nel 1941 e animato da Lidio Bozzini (studente all’Università di Roma e in contatto col citato presidente della stessa F.U.C.I. Aldo Moro). Al gruppo hanno aderito vari notabili locali, come Corrado Peruzzi[20]; l’esponente più rappresentativo è però il Conte Lucangelo Bracci, erede di una famiglia poliziana di tradizioni risorgimentali (avevano ospitato nel 1830 un incontro di Giuseppe Mazzini col patriota livornese Francesco Guerrazzi[21]) che vive fra la cittadina toscana e Roma (dove, nel salotto di casa sua in via IV novembre, si erano ritrovati per anni molti grandi antifascisti, come Piero Calamandrei, Emilio Lussu, Giovanni Amendola, i fratelli Rosselli e Gaetano Salvemini, che lì fu arrestato nel 1925[22]). A Montepulciano Bracci ha fondato una falegnameria, organizzata inizialmente in forma cooperativistica, che dirigerà a lungo; quando dovrà chiuderla regalerà ad ogni operaio gli strumenti e il banco di lavoro, perché possano continuare in proprio l’attività[23].
I cristiano sociali sono quindi dei cattolici di sinistra, piuttosto lontani dalla nascente Democrazia Cristiana, e più vicini a movimenti laici come “Giustizia e Libertà”, costituita a Parigi da esuli antifascisti di tradizione socialista e repubblicana, e poi al Partito d’Azione, fondato clandestinamente a Roma nel 1942.
L’Italia intanto, dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti – in aiuto, fra l’altro, degli inglesi – e le numerose sconfitte ad essa inflitte da parte di tali Alleati – è devastata dai bombardamenti; anche la Capitale non è più sicura ed Elio pensa bene di trasferire la mamma nella più tranquilla Montepulciano, dove va spesso a trovarla.
Durante una di queste visite si può collocare il ricordo di Giuseppe Momicchioli, all’epoca un ragazzo (poi medico dentista, nonché storico poliziano), che sta facendosi tagliare i capelli nel negozio del barbiere Francesco Caroti detto “Checco”, in via Roma, quando vede entrare “un signore alto, elegantemente vestito”; sono presenti l’avvocato Umberto Corsini ed altri notabili del paese che – tutti – si alzano in piedi e lo salutano molto calorosamente, per poi mettersi a commentare la situazione politica. Il ragazzo capisce che quel signore è l’ingegnere delle ferrovie di cui ha sentito parlare; solo molto tempo dopo comprenderà di essersi trovato in mezzo ad una riunione dei socialisti cittadini, che si vedevano in quel luogo tutti i sabato sera, e da lì tessevano i contatti con gli altri gruppi antifascisti[24].
Intanto gli Alleati angloamericani sbarcano in Sicilia; poco dopo, il 25 luglio 1943, il Re Vittorio Emanuele III fa cadere il regime, sostituendolo con un Governo militare che l’8 settembre firma l’armistizio con gli stessi Alleati; la situazione è però gestita talmente male che l’esercito si sfascia, mettendo in crisi la stessa legalità dello Stato monarchico. Tutto il centro-nord del Paese viene in pochi giorni conquistato dai tedeschi (solo il sud è presidiato dagli angloamericani), mentre Mussolini fonda sotto la protezione nazista un altro stato: la Repubblica Sociale Italiana, con un proprio governo, ministri, gazzetta ufficiale, ecc…, che si pone alla testa delle istituzioni e pubblici uffici nelle zone occupate. È evidente che si tratta di un fantoccio, chi comanda sono i germanici: la sovranità statale appare comunque liquefatta e molti italiani vogliono in qualche modo riprendersela, farla propria; decidono così di imbracciare le armi, convinti – come scriverà uno storico – che “non può esservi salvezza se non nell’autonoma responsabilità e nel coraggio sovrano del singolo”[25]. Costituiscono perciò bande armate autonome; altre bande nascono come dirette emanazioni dei partiti antifascisti, che intanto si collegano fra loro nei vari Comitati di Liberazione Nazionale, locali e centrale; altre ancora sono organizzate da militari sbandati fedeli – nonostante tutto – alla Monarchia. Questo mondo variegato e policentrico lentamente si aggrega, intorno al comune denominatore della lotta ai nazifascisti: inizia la Resistenza. Intanto i repubblichini di Mussolini decidono di trasferire i Ministeri da Roma (dove si pensa arriveranno presto gli angloamericani) al nord: la Direzione delle Ferrovie dovrebbe andare a Verona. Ma il Direttore Generale FS, Luigi Velani, riesce abilmente a procrastinare i traslochi, e si spostano in pochi; in particolare, nell’Istituto Sperimentale le sofisticate apparecchiature con cui si lavora vengono sì smontate e imballate; poi però parte solo un camion con qualche macchinario antiquato o addirittura guasto, il grosso resta lì; e pure il personale che si muove non è molto[26]. Bernabei rimane al suo posto di lavoro, pur avendo poco da lavorare.
Infatti fa ben altro: anch’egli si sente sovrano di sé stesso, è ora di agire. Con chi? I cristiano sociali sono una piccola organizzazione, presente in alcune località, compresa Montepulciano; ma non fanno parte del CLN centrale, che opera clandestinamente a Roma, dove la componente cattolica è rappresentata dalla ben più forte Democrazia Cristiana[27]; fra i partiti laici dell’Urbe c’è invece – ed è molto attivo – quello d’Azione, cui Elio aderisce[28].
Gli azionisti organizzano la loro resistenza nella Capitale su otto Zone territoriali, ognuna divisa in vari Settori. Bernabei fa parte della Prima Zona (fra San Pietro, Monte Mario, Prati, Primavalle e Trionfale) dov’è Caposettore Militare del III Settore (Piazza Mazzini, dove abita) e s’incarica con coraggio di compiti rischiosi: prepara squadre d’azione, partecipa ad azioni di sabotaggio, coordina il servizio stampa; per finanziare tali attività, investe parte dei suoi risparmi[29]. Arriva così a svolgere anche funzioni di Capo Zona[30] e si interfaccia col Comitato Militare del Partito (che coordina tutte le Zone) dove opera Armando Bussi, ferroviere pure lui, impiegato al Compartimento FS di Roma. Inoltre ospita nella sua casa un altro azionista di primo piano, Vincenzo Baldazzi detto “Cencio” – vecchio repubblicano antifascista rientrato ad agosto da un lungo periodo di confino a Ponza – che ha tuttora un largo seguito nei quartieri popolari della Capitale, e ricorderà sempre le loro lunghe conversazioni serali su quello che si stava facendo e sul futuro del Paese[31].
Il 22 gennaio 1944 gli angloamericani sbarcano ad Anzio; Bernabei attende da un momento all’altro l’ordine di un’insurrezione per liberare la Capitale. Ma tale ordine non arriva: i tedeschi sono riusciti a bloccare gli Alleati ed Elio, deluso[32], verso metà febbraio lascia l’Urbe per Montepulciano. E lì il già citato Giovanni Mariotti, mentre se ne sta nella sua baita in montagna, isolato da un’abbondate nevicata, se lo vede comparire sull’uscio, con scarponi, calzettoni e un giaccone pesante, “più simile a un buon signore di campagna che a un alto funzionario di città”. Di fronte al caminetto acceso, Elio si apre con l’amico: è in crisi, si chiede se valga la pena di correre senza ragione tanti rischi. Mariotti lo tranquillizza e – pur raccomandandogli molta prudenza – lo invita ad avere fiducia perché sull’esito finale della guerra non possono esserci dubbi[33]. Bernabei, rincuorato, passa ancora qualche giorno in paese, torna a trovare gli amici dell’Azione Cattolica, nonché gli antifascisti nella bottega di “Checco” Caroti, fornendo loro notizie sugli eventi della Resistenza romana; alla fine di febbraio saluta la madre e lascia la propria cittadina per tornare nell’Urbe[34]. Riprende così l’attività partigiana, ma va pure un’altra volta dai suoi poveri della borgata di Primavalle[35]. Non sa che non li rivedrà più: gli restano pochi giorni di libertà, e meno di un mese di vita.
Nella Capitale è arrivato fin da gennaio Pietro Koch, proveniente da Firenze, dove aveva operato in un reparto speciale della polizia repubblichina, diretto da Mario Carità. In realtà non si tratta di poliziotti di carriera, entrambi alle Questure erano noti per ben altri motivi: Carità è un ex piazzista di radio Philips, licenziato per truffa; Koch ha precedenti analoghi, ha evitato la prigione solo perché i suoi debiti sono stati ripagati dal padre Rinaldo, commerciante tedesco, la cui lingua il figlio parla benissimo[36]. È pure per questo che lo stesso Koch nel novembre ’43 – quando è solo un militare sbandato – si è offerto di collaborare coi nazifascisti, accolto a braccia aperte; e a Firenze la “banda Carità” si è distinta per efficienza e crudeltà nella lotta ai partigiani toscani. Koch, imparato il mestiere, si mette in proprio, costituendo nell’Urbe una squadra analoga – alle dirette dipendenze del Questore repubblichino Pietro Caruso – e ottiene vari successi. Riesce fra l’altro ad infiltrare fra gli azionisti alcuni delatori, come Gerardo Priori e Francesco Argentino, già collaboratore del servizio segreto militare[37]. Grazie a loro si può così preparare un elenco di partigiani con nomi e indirizzi ed arrestarne, fra il 1° e il 2 marzo, parecchi (compreso Armando Bussi). Bernabei si è mosso con prudenza, i traditori lo conoscono solo di vista, tant’è che in quell’elenco lui non c’è; purtroppo, come in un triste gioco dell’oca, in tasca di un arrestato trovano un taccuino, con l’indirizzo di un altro compagno (pare un certo Rizzo); la mattina del 3 i fascisti sono in casa di questi e stanno per portarlo via, quando squilla il telefono: è Elio. Il padrone di casa viene costretto a rispondere, e poi a passare il telefono a Koch stesso che, imitandone la voce, riesce a concordare un appuntamento a Piazza Cavour. I poliziotti non sanno che viso abbia il nostro, ma l’Argentino sì, e appena lui riconosce da lontano Bernabei gli saltano addosso e lo catturano[38]. È detenuto e torturato per un paio di giorni nella Pensione Oltremare di Via Principe Amedeo 2 (presso la Stazione Termini), dove la banda ha in quei giorni la sede operativa; intanto gli vanno a perquisire la casa[39]. “Cencio“ Baldazzi, più fortunato del giovane compagno, al momento della perquisizione non c’è, sfugge così all’arresto; torna più tardi diverse volte e, non trovandolo, capisce che anche lui è stato preso[40]. Il 5 marzo Bernabei è trasferito nel carcere di Regina Coeli; dalla prigione riesce a mandare ad un amico e collega dell’Istituto Sperimentale, il dr. Eugenio Strambi (che veniva pure lui dal senese, era di Montalcino), un lettera gentilissima[41], ove – scusandosi per il disturbo che gli sta arrecando – gli raccomanda la mamma – che pensa molto preoccupata di non riuscire a contattarlo – e lo prega di riferire alla donna un bugia, cioè che Elio si era dovuto nascondere per non essere trasferito al nord con la Direzione Generale FS. Un altro particolare ci dice come fino all’ultimo resti preciso ed attento, perfino all’igiene personale: è uno dei pochi a cui in tasca – poi – troveranno una bustina di “Mom” (un antiparassitario, in carcere i pidocchi dovevano essere diffusi)[42]. Sembra che abbia la possibilità di essere ricoverato in infermeria (dove ci sono vari compagni, che il 19 verranno prelevati dai tedeschi; ma riusciranno così a fuggire, e si salveranno[43]); Elio invece non ci va, vuole restare nella cella del 7° Braccio che divide con altri azionisti prigionieri, Ugo Baglivo e Carlo De Giorgio[44].
Alle 15,50 del 23 marzo 1944 un attentato partigiano in via Rasella fa 33 vittime fra i tedeschi, che subito decidono di uccidere dieci italiani per ciascuna delle loro vittime; le radunano in parte fra i loro prigionieri, gliene mancano però 50 che chiedono al Questore Caruso. La mattina del 24 costui – sentito il Ministro del Governo fascista Buffarini Guidi, e con l’aiuto di Kock – redige l’elenco e glieli consegna: ci sono quasi tutti gli azionisti appena arrestati, fra cui al primo posto Bussi, al sesto Baglivo, al nono De Giorgio e al decimo Bernabei. Così anche Elio viene preso dalla sua cella e portato all’ufficio matricola del carcere, dove un agente, ligio alle procedure, gli fa sottoscrivere l’uscita sull’apposito registro[45]. È la sua ultima firma. Non sono passate nemmeno 24 ore dall’attentato e già gli ostaggi sono sui camion diretti verso la via Ardeatina.
Il resto è storia. Il giorno successivo una scarna dichiarazione del Comando tedesco comunica che sono stati uccisi in un attentato 33 suoi soldati, che si è deciso di fucilare dieci italiani per ognuno di loro, e che “l’ordine è già stato eseguito”[46]. In tutta Roma la mancanza dei nominativi degli uccisi getta nell’angoscia ogni famiglia che ha persone in carcere, o che comunque non sa dove siano i propri cari.
Una settimana dopo le voci sull’accaduto sono arrivate anche a Montepulciano e per la mamma di Elio – da tempo senza notizie del figlio – comincia un’altalena di paure e di sempre più flebili speranze, che durerà quattro mesi. La signora Concetta si rivolge anzitutto al Vescovo della città Emilio Giorgi, un sant’uomo che si sta dando molto da fare in quei tempi, e pure in quest’occasione non indugia: affitta subito un’auto e, insieme con la donna, la sorella e un amico, si precipita nella Capitale: vanno a casa dei Bernabei (tutta in disordine per l’avvenuta perquisizione), a Regina Coeli (dove lui risulta essere stato detenuto fino al 24 marzo), all’Istituto Sperimentale dal dr. Strambi; infine da Amedeo Strazzera Perniciani – Presidente di un ente benefico, la Commissione di assistenza ai carcerati – a cui pochi giorni prima il citato Ministro fascista Buffarini Guidi aveva detto (pur in evidente contrasto con le dichiarazioni dei nazisti) che solo una settantina degli ostaggi erano stati uccisi, e gli altri invece trasferiti in alta Italia[47]. Purtroppo non vanno al comando della polizia e del servizio di sicurezza germanico, in via Tasso 155, che certo ha gli elenchi dei caduti, tant’è che alla fine di marzo da lì sono cominciate a partire, per le famiglie di varie vittime, lettere che danno, in tedesco, la notizia dell’uccisione[48]. Il gruppo torna perciò in Toscana temendo che il figlio di Concetta sia stato fucilato, ma senza averne la certezza, e la triste altalena continua. Ai primi di maggio un cugino di Elio, Luigi Baccheschi, scrive al Vescovo di aver ritirato in Questura, il 22 aprile, alcuni suoi effetti personali (una borsa con le chiavi di casa); ne mancano però altri (documenti, orologio e cappotto), per cui si può ancora sperare che sia stato portato altrove. Intanto il comando tedesco spedisce anche alla mamma di Bernabei, il 19 maggio, la comunicazione del decesso. Ma la invia all’indirizzo di Roma, dove non c’è nessuno[49], la donna la riceverà più tardi; così a fine mese Strambi manda pure lui una nota al prelato, dicendo che non ci sono novità e tutto è ancora possibile[50].
Il 4 giugno la Capitale è liberata dagli Alleati e si può finalmente ispezionare la cava sulla via Ardeatina, vedendo le dimensioni e la gravità dell’eccidio. Gli amici romani di Elio hanno così la conferma della sua morte, mentre il fronte di guerra spostato a nord di Roma (Montepulciano sarà liberata solo il 29) e altre difficoltà nelle comunicazioni impediscono i contatti con la povera madre.
Il 24 luglio si svolge una Messa dedicata al Caduto nella Chiesa di San Francesco a Ripa, in Trastevere, con successiva commemorazione presso il vicino Istituto Sperimentale, alla presenza del nuovo Direttore Generale FS Giovanni Di Raimondo; Strambi tiene un discorso a ricordo di Elio. Ma solo tre giorni dopo, il 27, al Vescovo Giorgi arriva una lettera, spedita il 10, che conferma definitivamente il decesso[51]; il prelato incarica così il parroco, Padre Anselmo Cicaloni, di informare la madre. Il sacerdote chiama due chierichetti, Giulio Isacchi e il già citato Giuseppe Momicchioli, dicendo loro di venire con lui, come fanno sempre nelle sue visite pastorali, a casa della Bernabei; all’uscio però stupisce i suoi accompagnatori perché, contrariamente al solito, vuole entrare da solo. Esce dopo un’ora, silenzioso e pallido, e torna verso il suo convento, sempre accompagnato dai due ragazzi nella cui mente – scriverà poi Momicchioli – “rimase solo il ricordo di quella tristezza di cui non capivamo la ragione ma che avevamo ugualmente condiviso”[52].
All’inizio di settembre gli esami medico-legali, svolti sulle vittime del 24 marzo in un laboratorio allestito all’interno delle cave Ardeatine, portano all’identificazione della salma di Elio; la sua bara è collocata insieme alle altre in una galleria dello stesso complesso[53]. Il 7 settembre ne dà notizia il quotidiano del Partito d’Azione “L’Italia Libera”; la Sezione di Montepulciano dello stesso Partito lo commemora il 17, con un lungo discorso di Mario Delle Piane[54]. Intanto si è costituita un’Associazione fra i familiari delle vittime della strage, che propone ai suoi aderenti la realizzazione nel luogo del martirio di un Mausoleo in cui seppellire i caduti; è interpellata anche la signora Concetta, che il 22 dicembre domanda invece la restituzione del figlio per portarlo a Montepulciano[55], nella Cappella di famiglia presso il Cimitero di Santa Chiara. Nel gennaio 1945 Bernabei viene così tumulato accanto al babbo e agli altri familiari. Commossi discorsi sono tenuti, fra gli altri, sia da Lucangelo Bracci, divenuto nel frattempo Sindaco[56], sia dai citati Umberto Corsini, a nome del C.L.N.[57], e Corrado Peruzzi, per l’Azione Cattolica[58]. Più tardi, il 15 luglio dello stesso anno, nel Municipio di Montepulciano viene collocata una lapide in suo ricordo.
La madre di Elio – la “sora Concetta”, come la chiamano tutti in paese – muore undici anni dopo, nel 1955, e viene sepolta anch’essa nella tomba familiare; lascia nel suo testamento un legato di £. 20.000 all’Istituto Sperimentale, perché vengano date (sempre tramite il dr. Strambi, con cui era rimasta in amicizia) a quattro bambini che – proseguendo nelle iniziative assistenziali che Elio predilegeva – erano stati adottati dallo stesso Istituto per onorarne la memoria[59]. Altri beni vanno alla Pia Arciconfraternita di Misericordia di Montepulciano per la gestione di un ricovero per anziani, costituito nel 1924 a seguito di un precedente lascito testamentario, della famiglia Cocconi; ricovero che oggi, col nome di Casa di Riposo Cocconi-Bernabei[60], ne perpetua il ricordo.
Sempre a Montepulciano, a Elio viene dedicata una strada con un’altra più recente lapide, questa inaugurata il 29 giugno 2013.
Venendo a Roma, il 24 marzo 1945, nel primo anniversario della morte, Bernabei viene commemorato dall’Istituto Sperimentale FS; stavolta chi lo ricorda è un diverso collega, l’ing. Pizzuto, che con lui aveva lavorato per un decennio[61]. In un altro 24 marzo di cinque anni dopo è prima officiata una Messa dal Vescovo Giorgi, sempre presso la Chiesa di San Francesco a Ripa in Trastevere; poi nella limitrofa sede dello Sperimentale si scopre una stele marmorea in onore del nostro, alla presenza di alte autorità statali e locali, fra cui il Sottosegretario ai Trasporti Bernardo Mattarella (padre del futuro Presidente della Repubblica Sergio) e l’allora Sindaco di Montepulciano Fosco Monni[62].
Nella Capitale possiamo altresì ritrovare il nome di Bernabei in una quarta iscrizione marmorea del giugno 1945, posta vicino San Pietro, in Piazza Pia, che lo cita fra i trenta caduti della Prima Zona del Partito d’Azione. Poi, il 24 marzo 1949, viene come noto inaugurato il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, con i sacelli di tutte le vittime, compreso quello di Elio Bernabei, al n.196; poiché non risulta che la salma vi sia stata effettivamente riportata da Montepulciano, possiamo considerare tale sacello, con molta probabilità, come una sorta di cenotafio, che gli rende onore ma è vuoto (non è del resto l’unico caso)[63].
Va infine citata un’ultima, più recente lapide, collocata nel 2013 al Binario 1 della Stazione di Roma Tiburtina, ove si ricorda come fra i 335 caduti alle Ardeatine ci sono in totale sei ferrovieri: oltre al nostro Elio, Michele Bolgia, il citato Armando Bussi, Mario D’Andrea, Renzo Piasco e Goffredo Romagnoli, che morirono, come vi è scritto, “per aver combattuto il fascismo, in nome di un’Italia libera, democratica e solidale”.
“Chi ha tempo e tempo aspetta, tempo perde“, scrisse una volta il Poliziano[64]. Ma certo – possiamo concludere – Elio Bernabei non perse il tempo breve dei suoi trentasei anni.
[1] Claudio Biscarini, “23 marzo 1944. I Caduti toscani alle Fosse Ardeatine”, Effigi 2015
[2] La genealogia è stata ricostruita da Graziano Bernabei, grazie anche alle informazioni ricevute dall’Archivio Storico della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza
[3] “Viaggio nella storia del nostro territorio: i garibaldini a Montelibretti nel 1867” su
[4] Giovanni Mariotti, “Resistenza e riscossa nella terra del Poliziano”, Le Balze, Montepulciano 2003, pagg.99/100
[5] Angiolo Del Corto, “Nel V anniversario dell’eroico sacrificio del Dott. Ing. Elio Bernabei trucidato dai tedeschi”, su “L’Araldo Poliziano” del 20 marzo 1949
[6] Fascicolo Personale FS di Elio Bernabei
[7] Fascicolo Personale FS di Elio Bernabei
[8] Fascicolo Personale FS di Elio Bernabei
[9] Registro Matricola del Carcere di Regina Coeli, marzo 1944
[10] Guido Corbellini, “Le Ferrovie dello Stato compiono cinquanta anni di vita”, in “Ingegneria Ferroviaria”, nn.5/6, C.I.F.I., maggio/giugno 1955, pag.353 nota 89; Giovanni Mariotti, cit., pag.106
[11] Fascicolo Personale FS di Elio Bernabei
[12] Discorso dattiloscritto intestato “24 marzo 1945 – 1° anniversario della morte dell’ing. Elio Bernabei Martire delle Fosse Ardeatine – Parole dell’ing. Pizzuto Istituto Sperimentale Ferrovie dello Stato Roma”, pronunciato presumibilmente nella sede dello stesso Istituto Sperimentale, o in altra sede ferroviaria. Vi si precisa che questi studi concernono: acciaio di qualità al cromo, manganese, rame; lamiere di acciaio Thomas; rotture su assi per elettromotrici e su chiavarde di motori diesel per navi traghetto; nuovi processi di fabbricazione e lavorazione (brunitura dei fuselli, framatura con processo Tecce, ramatura con processo Veralit)
[13] Giuseppe Momicchioli, “La Macchina del tempo”, Andrea Comunicazione 2016, pag.28
[14] Fascicolo Personale FS di Elio Bernabei
[15] Discorso cit. dell’ing. Pizzuto
[16] Discorso dattiloscritto firmato “Corrado Peruzzi per l’Azione Cattolica”, senza data; Discorso cit. dell’ing. Pizzuto; Guido Corbellini, cit., pag.353 nota 89; Giovanni Mariotti, cit., pag.106
[17] Giovanni Mariotti, cit., pag.103
[18] Alberto Bracci Testasecca, “Il treno”, Edizioni E/O, 2007, pag.9
[19] Matteo Polo, “Civiltà e libertà. Margherita Papafava e Lucangelo Bracci dalla Grande Guerra alla Repubblica”, Il Ponte, Firenze 2013, pag.264
[20] Matteo Polo, cit., pag.266
[21] Matteo Polo, cit., pag.18
[22] Matteo Polo, cit., pagg.217 e 246/248
[23] Matteo Polo, cit., pagg.250/251 e 309
[24] Giuseppe Momicchioli, cit., pag.28
[25] Giuseppe Filippetta, “L’estate che imparammo a sparare”, Feltrinelli 2020, pag.22
[26] Direzione Generale Ferrovie dello Stato, “Relazione per l’anno finanziario 1943-1944”, 1948, pag.149
[27] Matteo Polo, cit., pagg.262/263
[28] In proposito Giovanni Mariotti, cit., pag.104, annota che “politicamente aderiva alle fila del partito Cristiano Sociale, militarmente comandava le formazioni del partito d’Azione, pel settore di Piazza Mazzini”; tale notazione però, scrive il curatore del libro, risulta poi cancellata
[29] Discorso cit. dell’ing. Pizzuto
[30] Su “L’Italia Libera”, il 24 giugno 1944 è definito “Capo politico I zona”; il 7 settembre 1944 “Capo della I Zona”. Anche su “I Caduti del Partito d’Azione – 24 marzo 1944”, Et ultra 1945, pag.12, è definito “Capo della I Zona”; nella stessa pagina è però Ugo Baglivo ad essere chiamato “Capo politico della I Zona”. Secondo la ricostruzione di F.Fabrocile (“Radici politiche, caratteri e attività del Partito d’Azione nella lotta partigiana a Roma”, tesi di dottorato) i Capi della I Zona furono in successione Virgilio Olmeda, Fernando Norma e Giuseppe Rizzo, mentre Bernabei era Capo Settore militare del III settore (Mazzini) della Zona stessa; quest’ultima ipotesi sembra in parte confermata da Giovanni Mariotti, cit., pag.104, dove dice che ““politicamente aderiva alle fila del partito Cristiano Sociale, militarmente comandava le formazioni del partito d’Azione, pel settore di Piazza Mazzini””
[31] “I nostri Martiri – Elio Bernabei”, su “L’Italia Libera” del 7 settembre 1944, pag.2; Mario Delle Piane, “Elio Bernabei, Caduto per la giustizia e la libertà d’Italia il XXIX marzo MCMXXXXIV”, stampato a beneficio dell’Ufficio Assistenza del Partito d’Azione, pag.5
[32] “I nostri Martiri – Elio Bernabei”, cit., pag.2
[33] Giovanni Mariotti, cit., pag.104
[34] Discorso dattiloscritto firmato “Avv. Umberto Corsini a nome del Comitato di Liberazione”, senza data ma che dal contenuto appare pronunciato nel 1945 di fronte alla tomba di Bernabei a Montepulciano; discorso cit. di Corrado Peruzzi
[35] Discorso cit. di Corrado Peruzzi; discorso cit. di Umberto Corsini; Giuseppe Momicchioli, cit., pag.28
[36] Massimiliano Griner, “La Banda Koch”, Bollati Boringhieri, 2000, pagg.45/47 e 56
[37] Massimiliano Griner, cit., pag.74
[38] Archivio di Stato di Milano, “Procedimento contro il reparto speciale di polizia comandato da Pietro Koch”, cartella 5 Vol.21, “Interrogatori di Pietro Kock dal 23 maggio al 3 giugno 1945”, pag.43
[39] Claudio Biscardini, cit., pag.59
[40] “I nostri Martiri – Elio Bernabei”, cit., pag.2
[41] Giovanni Mariotti, cit., pagg.108/109; Conti, Tasca, Cingolani, “I martiri ardeatini – Carte inedite 1944-1945”, AM&D Edizioni, Cagliari 2012
[42] Conti, Tasca, Cingolani, “I verbali inediti di identificazione dei martiri ardeatini”, AM&D Edizioni, Cagliari 2012, pag.248
[43] Amedeo Strazzera-Perniciani, “Umanità ed eroismo nella vita segreta di Regina Coeli. Roma 1943-1944”, Ferri, Roma 1959, pag.131
[44] Giovanni Mariotti, cit., pag.108
[45] Registro Matricola del Carcere di Regina Coeli, marzo 1944
[46] Enzo Piscitelli, “Storia della Resistenza Romana”, Laterza, Bari 1965, pagg.299/300
[47] Claudio Biscardini, cit., pagg.59/60; Amedeo Strazzera-Perniciani, cit., pag.146
[48] www.mausoleofosseardeatine.it”, Archivio ANFIM, vedi ad es. il Fascicolo personale di Filippo De Grenet, alla cui famiglia la comunicazione fu mandata il 30 marzo
[49] “www.mausoleofosseardeatine.it”, Archivio ANFIM, Fascicolo personale di Elio Bernabei
[50] Giovanni Mariotti, cit., pag.106
[51] Giovanni Mariotti, cit., pagg.98/109; Leopoldo Boscherini, “La Sulla è fiorita – La Liberazione di Montepulciano”, Le Balze, 2004, pag.20
[52] Giuseppe Momicchioli, cit., pagg.28/29, ove l’episodio è datato ad aprile, il che però appare improbabile
[53] Attilio Ascarelli, “Gli eccidi nazifascisti come radice della Carta Costituzionale”, A.N.F.I.M. 1997, pagg.73 e 94
[54] Mario Delle Piane, cit.
[55] “www.mausoleofosseardeatine.it”, Archivio ANFIM, Fascicolo personale di Elio Bernabei
[56] Discorso dattiloscritto firmato “Lucangelo C.te Bracci Sindaco di Montepulciano”, senza data ma che dovrebbe risalire – considerando che dal contenuto risulta pronunciato nel 1945 e che il Bracci fu Sindaco fino al gennaio di quell’anno (vedi Matteo Polo, cit., pag.288) – appunto all’inizio del 1945, in occasione del funerale di Bernabei in Montepulciano
[57] Discorso cit. di Umberto Corsini
[58] Discorso cit. di Corrado Peruzzi
[59] Fascicolo Personale FS di Elio Bernabei
[60]“www.misericordiamontepulciano.it”
[61] Discorso cit. dell’ing. Pizzuto
[62] “I ferrovieri hanno elevato a Roma una stele marmorea ad Elio Bernabei, martire delle Ardeatine”, articolo firmato b.m., senza nome della rivista né data; data che invece risulta chiaramente nella notizia sull’inaugurazione della stessa stele fornita in fondo all’articolo “Il VI anniversario dell’eccidio delle Ardeatine nella solenne commemorazione di oggi”, su “Il Messaggero” del 24 marzo 1950, pag.2
[63] La Direzione del Mausoleo delle Fosse Ardeatine – interpellata in merito evidenziando che nel 1945 c’era stato il funerale di Bernabei a Montepulciano – ha risposto che “risulta tumulato presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine”, senza però fornire documentazione in merito. Caso analogo è quello di Manlio Gelsomini, cui è intestato il sacello n.34, ma risulta sepolto al Cimitero romano del Verano.
[64] “Rispetti continuati” in “Le Stanze, l’Orfeo e le Rime di Messer Angelo Ambrogini Poliziano”, con saggio introduttivo di Giosuè Carducci, G. Barbera Editore, Firenze 1863, pag.192