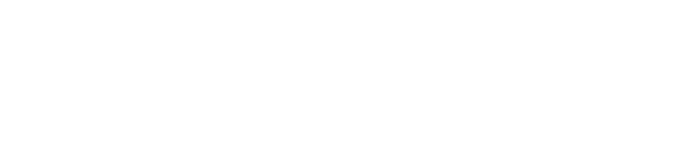Uno studio sulla complessità dei campi di concentramento: “The Complete Lives of Camp People” di Rudolf Mrázek
Rudolf Mrázek
The Complete Lives of Camp People- Colonialism, Fascism, Concentrated Modernity
Durham (USA, South Carolina), Duke University Press, 2020
L’autore del libro è nato a Praga nel 1942. Ha lungamente insegnato in una università americana, Ann Arbour nel Michigan, come specialista di storia dell’Indonesia. Nei suoi studi sul campo (field) si è imbattuto in un campo (camp)per prigionieri politici comunisti, messo su dagli Olandesi negli anni venti, Boven Digoel, e ha intervistato superstiti e figli e nipoti degli internati. Una volta pensionato, nei soggiorni più frequenti nella città natale, a lungo impossibilitati dopo la repressione della primavera praghese, si è appassionato alle vicende del campo di concentramento di Theresienstadt (la denominazione tedesca ora abbandonata recuperando l’antico Terezin) e ha cominciato a raccogliere documentazione e interviste sia in Cechia che in Israele che in Olanda. Negli archivi di Amsterdam trovava riunita documentazione tanto sul campo di Boven Digoel dell’epoca coloniale che sugli internati ebrei olandesi nel campo vicino Praga. Come se si riunissero le fila della sua ricerca storica. Un campo di internamento per rivoluzionari comunisti (in gran parte mussulmani) ed un campo di concentramento di ebrei, sia pure differente da Auschwitz, in quanto riservato ad una élite e non di sterminio, una sorta di campo modello sul quale i nazisti girarono addirittura un documentario per vantarne le condizioni idilliache.
Rudolf mi ha raccontato che l’accostamento tra i due campi gli ha come provocato un clic: come se indagando su qualcosa (il campo indonesiano) si fosse imbattuto in qualcos’altro: il ricordo di Praga e la sensazione giovanile che a Praga “mancasse qualcosa”, finalmente elaborata nella consapevolezza che mancavano gli ebrei, un terzo della popolazione praghese prima della guerra, e questi ebrei erano finiti nel ridente paesino di vacanze di Terezin, trasformato in campo, insieme a tanti venuti dall’Olanda.
Il suo saggio ha un approccio innovativo all’universo concentrazionario, accostando esperienze lontane, colonialismo e fascismo, cercando di estrarne gli elementi caratterizzanti. È un saggio storico filosofico antropologico, in compagnia di autori a lui cari come Kafka e Benjamin, che gli sembra abbiano anticipato nell’immaginario la condizione concentrazionaria, senza prescindere da Heidegger, se pur poco affine.Questo approccio lo aveva già utilizzato nei suoi precedenti studi sul colonialismo olandese in Indonesia, come Engineers of Happy Land (Princeton 2002), combinando tecnologie e modi di pensare, moda e sistemi di comunicazione, impatto della cultura europea nella società coloniale, poesia e statistica. E l’attenzione alla memoria, filtrata attraverso autori come Proust e Kafka, era presente anche nello studio sugli intellettuali indonesiani A Certain Age, Colonial Jakarta through the Memories of Its Intellectuals (John Hope Franklin Center 2010).
Stavolta l’ambizione è di riunire gli ebrei della modernità, perseguitati e marginali di luoghi differenti, al di là degli Ebrei con la E maiuscola.
Cosa ci può essere in comune tra una prigione in Nuova Guinea ai margini della foresta tropicale, dove sono concentrati i comunisti che hanno partecipato alla rivolta del 1926-27 contro la dominazione olandese, e il campo per gli Ebrei a Terezin? Mrázek lo evidenzia attraverso un’analisi antropologica, che va dagli abiti, alle attività sportive e culturali, ai suoni e alla musica, all’architettura e alle condizioni igieniche e sanitarie, creando accostamenti audaci e attingendo abbondantemente alle memorie e alla letteratura.
Le luci, l’illuminazione, gli intellettuali illuminati, la penombra (Parte III): l’essere nel mondo di Heidegger in uno spazio artificialmente ripulito (una radura nella giungla) o rimesso a nuovo dopo averne evacuato gli abitanti (la cittadina di villeggiatura in stile rococò a pochi chilometri da Praga). Una esperienza estrema della modernità, una luce concentrata che poi i sopravvissuti espanderanno nel mondo, una volta dispersi, allargando la radura.
Scrivere dei campi, con Barthes, non può che essere scrivere nel panico, in fuga, sbirciando all’indietro di sbieco sopra una spalla. Tra i sopravvissuti l’autore non ha incontrato i tipi descritti da Canetti, trionfanti della loro sopravvivenza, orgogliosi della propria forza di resistenza. Quelli che ha intervistato avevano memorie labili, avvolte nella nebbia, e mani tremolanti, forse per l’età avanzata.
Ma quanto ricostruisce gli appare una rappresentazione significativa della nostra modernità.
(Silvia Calamandrei)