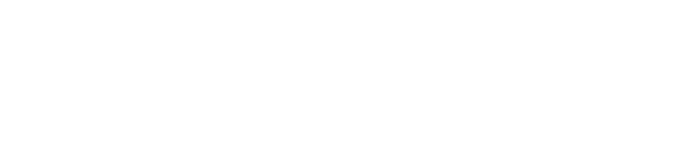Un letterato alla prova con la letteratura: “Amori sospesi” di Alberto Asor Rosa
Alberto Asor Rosa
Amori sospesi
Torino, Einaudi, 2017
Nell’ultimo decennio Alberto Asor Rosa ha affrontato una serie di prove narrative che alternano il racconto lungo autobiografico alla forma del racconto breve, attingendo alla sua esperienza di vita e di meditazione filosofica, nutrita di un denso bagaglio letterario che arricchisce la scrittura e i riferimenti. Non rinunciando al suo ruolo di commentatore politico e militante e alla sua sapienza di critico letterario, si dedica a questi esercizi di scrittura quanto mai godibili dai suoi lettori.
Dopo i “racconti dell’errore”, ecco questi frammenti di discorso amoroso sull’incompiutezza, gli “amori sospesi” che fanno intravvedere e sfiorare l’abisso dell’ineffabile e della perdita. Innamoramenti adolescenziali e senili che fanno subitaneamente fuoriuscire da uno stato di solitudine, che annunciano il miracolo dell’incontro, del ritrovarsi e del riconoscersi, miracolo intravvisto ma raramente avverato. Malinconia e squallore, o peggio abitudine e rassegnazione sembrano minacciare gli attimi di felicità e consumarli inesorabilmente.
Il racconto più lungo è una espansione, un prolungamento di Trippoli, la vicenda del professore di latino e greco che scopre in una allieva la capacità di recitare alla perfezione la poesia classica greca e i canti dell’Odissea, piombando l’auditorio in una esperienza di ascolto irrepetibile, di fruizione di una musicalità linguistica che pare scaturire dall’epoca di Saffo e di Alceo, comunicando una emozione ineffabile. L’autore si è sentito investito dalla sorte del personaggio, irrimediabilmente segnato, ed ha voluto raccontarne il percorso successivo, di ritiro dal mondo per l’elaborazione del lutto della dipartita di Elisa, trasferita altrove
Il suo spegnersi a fine stagione in una pensioncina sul mare, accasciato su una sedia a sdraio, fa da contrappunto all’esperienza più vitale del Vecchione e la bella fanciulla, l’incontro su una spiaggia deserta tra un vecchio ritiratosi in solitudine da anni in un capanno tra le dune ed una giovanissima bellezza che ogni giorno si spinge fino a lui nella sua passeggiata solitaria in riva al mare. Ne nasce una consonanza, un affiatamento nelle brevi nuotate fino alla secca, un’attesa reciproca, durata pochi giorni ma quotidianamente rinnovata, finché il vecchio interrompe bruscamente e coraggiosamente l’intesa, dichiarando che le stagioni della vita sono troppo lontane e diverse: per lui “questa è l’ultima spiaggia”.
C’è una forza nella rinuncia che precipita nella furia e nel pianto la bella fanciulla: è una accettazione della solitudine che tanto lo aveva fatto soffrire bambino, quella descritta nel primo racconto, La prima volta, sulla separazione dalla madre il primo giorno di scuola:
In mezzo a tutto quel fracasso, in mezzo a quel brulicare di mani, gambe , piedi, occhi, capelli e grida, lui era rimasto solo, lui era stato lasciato solo. Non lo avrebbe mai dimenticato.
Esperienza autobiografica e osservazione del mondo si mescolano all’introspezione sui temi eterni della vita e della morte, della fede e della ragione; particolarmente congeniale all’autore l’ atmosfera di una Roma di qualche decennio fa, di impiegati e commessi, usi ad abitudini e riti che si infrangono repentinamente per un accendersi della curiosità o del sentimento: dare un nome ad esistenze anonime, nominare individualizzando, è già un riconoscimento dell’altro, una agnizione, una uscita dalla solitudine. Rosetta, Erminia, Edvige, Irene, figure femminili che si tenta di possedere varcando la distanza.
(Silvia Calamandrei)