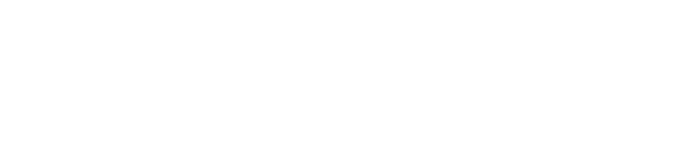il libro della settimana…dal 18 al 23 ottobre 2011: “Beni comuni” di Ugo Mattei
Ugo Mattei
Beni comuni: un manifesto
Roma-Bari, Laterza, 2011
Custodendo beni comuni, quali l’archivio storico, gli archivi del novecento e fondi librari antichi e moderni, la tematica dei “beni comuni” sollevata dai recenti referendum sull’acqua e l’energia ci interessa molto da vicino.
Segnaliamo dunque questo tentativo di sistemazione teorica del giurista Ugo Mattei, che in questo “manifesto” puntualizza una serie di riflessioni sul diritto che sono state alla base del suo contributo alla redazione dei quesiti del referendum, assieme a Stefano Rodotà, quest’ultimo protagonista della Commissione istituita nel 2007 da un decreto del Ministro della giustizia per elaborare una riforma del codice civile nelle parti relative alla proprietà pubblica.
Collocandosi in posizione intermedia tra pubblico e privato, i beni comuni si caratterizzano, secondo tale Commissione, per l’accessibilità a tutti, “declinando la logica dell’inclusione, totalmente antagonista a quella classica dell’esclusione, che conferisce valore alla proprietà sotto forma di rendita”.
Sempre secondo tale Commissione, “vanno collocati fuori commercio” e devono essere gestiti con strumenti a vocazione pubblicistica (nel senso ampio di estranei alla logica del profitto privato) al fine primario di soddisfare i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti e informati al principio di eguaglianza e solidarietà “anche nell’interesse delle generazioni future”.
Tali beni sono comuni anche indipendentemente dalla loro collocazione all’interno dei confini dello Stato sovrano nell’ambito del quale si trovano: sono collegati all’idea di patrimonio comune dell’umanità.
I lavori della Commissione hanno trovato sbocco in un disegno di legge, che è stato sostenuto dalla regione Piemonte; ma nessun partito politico se ne è fatto sostenitore.
Eppure, dopo i risultati del referendum e mentre si preannuncia la possibile messa in vendita di parte del patrimonio pubblico, la sistemazione giuridica di questi aspetti è quanto mai urgente.
La mente va al discorso recentemente ritrovato di Piero Calamandrei sul patrimonio artistico da salvare dopo i danni della guerra, in cui si contestava la definizione patrimoniale dei beni culturali ed artistici.
Nel 1952 Calamandrei dichiarava “inadeguata e goffa l’espressione di “patrimonio artistico” che comunemente si usa per indicare le opere d’arte di un paese: il patrimonio nel linguaggio dei giuristi è espressione che si riferisce alle cose, ai beni materiali, alla ricchezza, universitas rerum: qualcosa di distaccato, che riguarda l’avere, non l’essenza, qualcosa che si contrappone alla persona, e che si può perdere senza che la persona sia menomata”.
Invece, secondo lui,”le opere d’arte riguardano l’Essere, la civiltà, lo spirito di un popolo. Sono vita, sono parte della nostra vita, del nostro spirito: non si possono perdere senza sentirsi mutilati, menomati nello spirito. Se un capolavoro d’arte si distrugge, è una zona della nostra memoria che si oscura”.
Ed aggiungeva:
“Dunque io vengo qui a parlarvi non di un patrimonio impoverito, ma di una minaccia di oscuramento che pesa sul nostro spirito: non come esperto d’arte, che io non sono, e neanche come italiano che venga qui a lamentarsi delle sue disgrazie domestiche, ma come un quisquis de populo a cui sta a cuore un problema che non è dell’Italia soltanto, ma che è di tutto il mondo, poiché le opere d’arte italiane sono vostre come nostre, sono di tutti, e più siamo a possederle, più siamo felici e ricchi: e questa è la sola ricchezza che conta”.
In questo approccio c’è la messa in discussione della mercificazione dei beni culturali e la sottolineatura di un’appartenenza universale.
Sono temi da tenere presenti anche nella mobilitazione in corso per la difesa del patrimonio archivistico a cui aderiamo come Istituzione.
(Silvia Calamandrei)