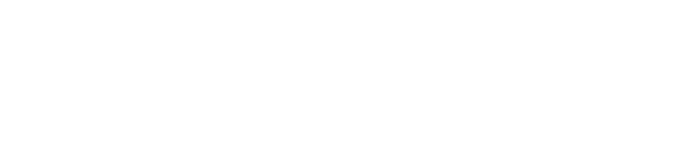Un’italiana in Cina: intervista a Tatiana Camerota
Siamo lieti di pubblicare un’intervista alla Dott. Tatiana Camerota, nostra collaboratrice per la gestione delle collezioni di lingua e cultura cinesi, che è appena rientrata da una bella esperienza d’insegnamento della lingua italiana in Cina.
(a cura di Silvia Calamandrei)
Chi sono gli studenti cinesi che studiano italiano per venire in Italia?
Ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni. I più giovani hanno terminato la scuola superiore in Cina e vogliono frequentare l’università in Italia, gli altri hanno invece già completato gli studi universitari di primo livello in Cina – quattro anni – e scelgono l’Italia per specializzarsi (o per cambiare e studiare un’altra disciplina). Le motivazioni sono generalmente di due tipi: o non hanno superato il gaokao, il difficile esame di ammissione all’università pubblica cinese, o l’hanno superato con un punteggio basso che non consente loro l’accesso alla facoltà desiderata, oppure per volontà e desiderio (loro e spesso dei genitori) di studiare all’estero per avere una formazione più completa, di impronta internazionale.
Prima di venire in Italia, quindi, gli studenti si rivolgono a delle agenzie specializzate che svolgono un po’ la funzione di intermediari e “facilitatori”, occupandosi di tutte le fasi preparatorie al viaggio in Italia e fungendo anche da ponte tra studenti e università cinesi e italiane. Dalla promozione dell’Italia al corso di lingua, dalla preparazione della documentazione necessaria alla richiesta del visto fino alla scelta dell’università con successiva pre-iscrizione, queste agenzie seguono ogni tappa degli studenti, avvalendosi sempre di insegnanti madrelingua che possono così abituarli a parlare italiano e raccontargli dell’Italia, in maniera diretta e divertente.
Possiamo infine identificare due tipologie di studenti: coloro che si inseriscono nell’ambito dei progetti Marco Polo e Turandot – accordo intergovernativo tra Italia e Cina, stipulato nel 2004 per incrementare e favorire la presenza di studenti cinesi nelle università italiane e che prevede sei o otto mesi di studio intensivo della lingua italiana presso l’Università per Stranieri di Siena e Perugia per poi iscriversi a un corso di laurea – e gli studenti internazionali, che invece arrivano solitamente nel mese di settembre e iniziano direttamente un corso universitario, triennale o magistrale.
Cosa sanno?
Per quanto riguarda l’Italia, inizialmente poco o nulla. Notizie e informazioni vaghe e generiche, acquisite in parte tramite Internet e in parte grazie alla fama internazionale che abbiamo ormai guadagnato in tutto il mondo in merito ad arte, cibo, bellezze naturali, musica classica e alle altre tipicità che identificano il Bel Paese nel mondo. È questo il motivo principale per cui scelgono l’Italia, pur non avendone una esatta cognizione. Manca tuttavia una vera consapevolezza sul loro luogo di destinazione e su quello che andranno a fare. Credo che abbiano una buona dose di coraggio misto a ignoranza e incoscienza; fortunatamente non vengono lasciati soli, quantomeno nelle fasi iniziali.
Per colmare queste lacune e dare un senso più concreto alla loro futura esperienza all’estero, all’interno dei corsi di lingua si affrontano anche temi culturali, che spesso fanno direttamente parte della quotidianità italiana, si parla delle problematiche che dovranno affrontare, delle principali faccende da sbrigare, delle attività e dei viaggi da fare, cercando in sostanza di fornire gli strumenti – linguistici e non – per non essere del tutto impreparati al loro arrivo e non parlare dell’Italia in maniera troppo astratta.
Da un punto di visto linguistico, attraverso il corso di italiano in Cina si cerca di fornire quantomeno una competenza di base sufficiente per muovere i primi passi nella realtà italiana. Competenza che va senz’altro rafforzata una volta in Italia e del tutto insufficiente per affrontare l’università, ma pur sempre un punto da cui partire, a patto che gli studenti ci mettano poi l’impegno necessario.
Cosa si aspettano?
Le aspettative – soprattutto delle famiglie – sono molte: arricchire il proprio bagaglio linguistico-culturale, fare esperienze nuove, andare all’estero e diventare indipendenti, maturare, viaggiare e, soprattutto, prendere un titolo di studio spendibile poi in Cina nel mondo del lavoro. La maggior parte degli studenti intende infatti rientrare in Cina al termine degli studi, per cercare un lavoro che gli piaccia e che soprattutto gli fornisca una buona posizione – sia a livello economico che di prestigio. I genitori dei ragazzi cinesi investono tantissimo nell’istruzione e nella formazione dei loro figli, mettendo nel corso di molti anni da parte i soldi proprio per questo scopo.
Su quali studi puntano?
Negli ultimi anni sono aumentati notevolmente gli studenti che scelgono di iscriversi ai Conservatori di musica e alle Accademie di Belle Arti, e non a caso, visto il nostro grande patrimonio sia artistico sia nel campo della musica classica. Un altro settore che sta riscuotendo grande successo è quello della moda, della grafica e del design. Non mancano tuttavia coloro che decidono di studiare Ingegneria presso il Politecnico di Milano o di Torino, piuttosto che Economia o Lingue, anche se queste ultime discipline in misura minore.
Quanto si impegnano?
Per quanto riguarda il corso di italiano in Cina, tendenzialmente e mediamente l’impegno non è tantissimo. Ciò è principalmente dovuto al fatto che molti studenti non sono ancora pienamente consapevoli delle difficoltà linguistiche che si troveranno ad affrontare in Italia o non sono del tutto motivati. Sono comuni quindi la pigrizia e il fare il minimo indispensabile. È bene quindi ribadire loro che questa tappa è fondamentale, perché migliore sarà la loro preparazione linguistica al loro arrivo in Italia e minori saranno le difficoltà che inevitabilmente incontreranno. Tra gli studenti che ho avuto io, devo dire che ne ho incontrati anche alcuni particolarmente brillanti, diligenti, motivati. E in questi casi il piacere di poter contribuire, attraverso l’insegnamento dell’italiano, alla loro formazione è di gran lunga maggiore.
Per quanto riguarda l’Italia, dipende. Trovandosi faccia a faccia con la realtà universitaria, con i problemi legati alla comunicazione e con il dover in qualche modo cavarsela da soli, l’impegno indubbiamente aumenta.
Differenze tra le tre città in cui sei stata.
Ho vissuto tre mesi decisamente intensi! In questo breve lasso di tempo ho girato tre città e lavorato in ciascuna di esse, e se da un lato non facevo in tempo ad ambientarmi ché subito dovevo cambiare, dall’altro ho avuto la possibilità di conoscere luoghi diversi, di scoprirne le peculiarità e di rendermi ancora più conto di quanto sia eterogenea la Cina, anche da un punto di vista ambientale e geografico. La prima città dove ho lavorato è Chengdu, capitale della provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale. Famosa per i panda, per i cibi piccanti e per il suo dialetto spesso incomprensibile agli stessi cinesi, è una città vivace, in continua e rapida costruzione, con una parte moderna e una parte più tradizionale, come del resto molte città cinesi. Rappresenta ormai uno dei principali centri economici e di comunicazione della Cina occidentale, e basta spostarsi di poche decine di chilometri per immergersi nella natura e nella campagna e scoprire località tipiche e incantevoli.
La seconda città è Shijiazhuang, nel Nord della Cina, capitale dell’Hebei a circa 300 km da Pechino. Devo dire che rispetto alle altre due città non mi è piaciuta granché, offre sicuramente meno in termini di patrimonio storico-culturale e intrattenimento, è più anonima, senza una forte identità. È una città industriale, sviluppatasi e ingranditasi negli ultimi decenni. Vi si possono ormai tranquillamente trovare centri commerciali di lusso e hotel a cinque stelle (per uomini d’affari), a pochi passi dalla povertà e dalla vita frugale della maggior parte della popolazione. Una contraddizione tipica della Cina attuale.
E infine Pechino, dove ero già stata due anni fa e dove sono quindi riuscita a muovermi senza troppe difficoltà. Parlarne richiederebbe troppo tempo e spazio; sintetizzando dico che nella capitale, centro e simbolo politico e culturale della Cina, puoi trovare ormai tutto e il contrario di tutto, in base alle tue esigenze. I ritmi di vita sono indubbiamente più frenetici, il traffico spesso insostenibile, l’aria respirata ti fa talvolta venire voglia di tornare a casa. Ma le sue bellezze, l’ambiente multiculturale e le opportunità offerte controbilanciano. Tradizione e modernità, lusso e povertà, oriente e occidente, sviluppo e degrado si fondono in un equilibrio talvolta precario.
Tra queste tre città, nonostante mi sia piaciuta molto Chengdu, la mia preferita resta pur sempre la capitale.
Gioventù cinese comparata con quella italiana.
I ragazzi cinesi sono generalmente ipertecnologici, amanti del web, dei videogiochi, del gossip e delle ultime tendenze della moda o dello spettacolo.
Tuttavia, fino all’università, la parola-chiave è “studio”, poi diventerà “lavoro” o “successo”: ottenere qualcosa in un modo o nell’altro, sistemarsi, diventare qualcuno o diventare ricco.
Sicuramente nello studio sono più allenati rispetto a tanti studenti italiani, ma questo dipende essenzialmente dal sistema che li “costringe” a stare sui libri – tra scuola e casa – per la maggior parte del loro tempo. Un sistema che però è troppo incentrato sull’imparare (a memoria) nozioni e che lascia poco spazio all’immaginazione e allo sviluppo di un pensiero libero e critico. Anche nella mia breve esperienza di insegnamento, mi sono accorta che gli studenti tendono a non andare oltre, a non chiedersi e capire il perché di una determinata cosa, ma a darla per scontata così com’è. Nello stesso contesto, ho anche notato che, se in possesso dei giusti stimoli, sono in grado di stupirti e di intrattenerti piacevolmente. I ragazzi – studenti e non – da me conosciuti sono sempre stati particolarmente accoglienti, gentili, simpatici: mi sono trovata piuttosto bene con loro, con rare eccezioni.
Se dovessi – scherzosamente – categorizzare, potrei dire di aver conosciuto diverse tipologie di cinesi: il cinese “addormentato” (colui che vive illusoriamente in un fantastico mondo dei sogni o bolla di sapone – ma prima o poi dovrà necessariamente svegliarsi e fare i conti con la realtà), il cinese brillante e ironico (ebbene sì, ce ne sono, e non pochi), il cinese indifferente (qualunque cosa succeda, non lo riguarda, per lui conta solo il proprio orticello), il cinese furbo (che aspira esclusivamente al raggiungimento di soldi e potere). Il “gruppo” che mi piace meno è sicuramente quello degli indifferenti. Ho infatti notato una scarsa conoscenza e consapevolezza del mondo in cui vivono, delle questioni (politiche, sociali, economiche e culturali) che dovrebbero invece riguardarli e poca volontà e interesse a informarsi su quanto accade. Una (apparente) superficialità. In questo trovo forse qualche analogia con parte della gioventù italiana. Ma sia ben chiaro: una regola ha sempre (molte) eccezioni, e sarei ben lieta di conoscerle!
Divertimenti
Il principale divertimento dei cinesi è il famoso KTV, ovvero il karaoke. In ogni città cinese esistono numerose strutture preposte esclusivamente a questa attività. Ciascuno può prenotare una saletta – super tecnologica, insonorizzata e con tanto di cibo, bevande e divanetti – per il proprio gruppo e trascorrere un pomeriggio o una serata in compagnia di amici, ballando, chiacchierando, mangiando, bevendo, dormendo ma soprattutto cantando canzoni cinesi (o straniere) tra le tante a disposizione. Un’abitudine radicata, ormai. Come per noi andare al bar o in pub. Tant’è che molti studenti mi hanno spesso chiesto, preoccupati: “Ma in Italia non c’è il KTV?”
Un altro intrattenimento comune è il cinema, dove si recano molti ragazzi e giovani coppie; oltre alle nuove uscite cinesi, tra i film stranieri in prima linea troviamo i film americani, soprattutto quelli di azione, fantascienza e avventura. Una nota interessante. I film stranieri – per di più americani, per l’appunto – vengono spesso proposti in doppia versione: lingua originale con sottotitoli cinesi e doppiati in cinese, cosicché chi ha voglia di praticare l’inglese può farlo.
Altra attività divenuta simbolo della cosiddetta “classe media” cinese, dove trascorrere soprattutto il fine settimana, sono i centri commerciali, presenti ormai in ogni dove e in varie tipologie, per tutte le tasche e i gusti: dalle marche di lusso, a quelle internazionali a quelle più a buon mercato.
Anche i locali – pub e discoteche – sia in stile occidentale che cinese (e talvolta in un bizzarro mix) stanno ormai prendendo sempre più piede tra i giovani cinesi, che stanno scoprendo questa nuova forma di divertimento e hanno così anche modo di conoscere nuove persone, spesso stranieri – studenti o lavoratori che vivono in Cina. Il bello di questi posti è proprio il clima e l’atmosfera multiculturali che vi si respirano.
Quanto sei riuscita a comunicare ed entrare in sintonia?
La questione linguistica è probabilmente quella che più mi appassiona. Per me che ho studiato e continuo a studiare la lingua cinese si tratta di una sfida continua, a metà tra frustrazione e soddisfazione, in base a quanto sono in grado di comunicare. Comunicazione che, all’inizio della mia esperienza, non è stata molto buona, sia perché ogni volta che si torna in Cina occorre riprendere un po’ i ritmi e “rifare l’orecchio” sia perché mi trovavo a Chengdu dove tutti conoscono il mandarino ma molti parlano poi il dialetto. Lentamente la qualità della comunicazione è andata migliorando, consentendomi di portare a termine conversazioni interessanti anche con la gente del posto e di scoprirne aspetti che prima sconoscevo. È bello parlare con i locali, ascoltare le loro storie, stupirsi per delle bizzarrie che per loro rappresentano invece la quotidiana normalità. Da non tralasciare è, a tal proposito, l’aspetto culturale: la lingua non può prescindere da essa, e al tempo stesso rappresenta il ponte diretto per conoscere la cultura di un popolo. Ritengo dunque che se si riesce a comunicare nella lingua del posto, si riuscirà in maniera più completa, senza filtri, a capirne la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi.
Inoltre, l’unico modo che si ha per imparare bene una lingua, oltre a una buona base teorica, è praticarla, buttarsi, parlare, sbagliare, e alla fine imparare. Questi tre mesi sono stati utilissimi per me per quanto riguarda lo sviluppo di una più profonda consapevolezza linguistica e sicurezza. E iniziare progressivamente meno a sentirsi un pesce fuor d’acqua, è una bella soddisfazione. Per far ciò, però, sono necessarie tanta tenacia, pazienza e soprattutto passione.
Cosa ti hanno dato questi mesi come esperienza e conoscenza?
Questa è stata la mia terza esperienza in Cina, che è sicuramente diversa dalla prima e dal primo impatto-choc che spesso si prova a contatto con un mondo diverso dal nostro. Tuttavia, ogni esperienza è a sé e anche quella appena trascorsa – da maggio a luglio scorso – mi ha dato tanto. Un “tanto” che ha per me un significato profondo, che provo qui a elencare per sommi capi:
crescita personale, mettersi continuamente in gioco e alla prova, maggiore sicurezza, miglioramento linguistico, possibilità di viaggiare e dunque scoprire posti e culture, confrontarmi con il diverso, affrontare e risolvere difficoltà quotidiane. E soprattutto la consapevolezza-certezza che la Cina e il cinese, in un modo o nell’altro, faranno parte del mio futuro. Ritengo di aver messo delle basi piuttosto solide, sia relazionali sia linguistiche. Voglio continuare a viaggiare e a scoprire questo paese che, nel bene e nel male, continua a stupirmi: affascinante, frenetico, complesso, misterioso, contraddittorio. Per tutti gli interessati e gli appassionati: un Paese da vivere e da scoprire!
Un consiglio che, molto umilmente, mi permetto di dare a chi conosce poco della Cina o, peggio ancora, ne è “spaventato” o “infastidito”. Indubbiamente gli aspetti negativi non mancano, ma è sempre sbagliato approcciarsi a un nuovo ambiente con il pregiudizio, perché inevitabilmente questo influirà comunque. Bisogna sempre cercare di andare a fondo in tutte le questioni, e allora – e solo allora – le conosceremo e avremo tutto il diritto di giudicarle, argomentando.
Per aumentare la reciproca conoscenza, a mio parere entrambi i paesi, Cina e Italia, dovrebbero promuovere maggiormente, al di là della cooperazione economica che pure è importante, quella culturale. Abbiamo due patrimoni storico-culturali immensi, molti studenti vengono da noi così come noi andiamo da loro. Approfittiamo di ciò, valorizziamo le potenzialità e pensiamo ai vantaggi che ne deriverebbero.